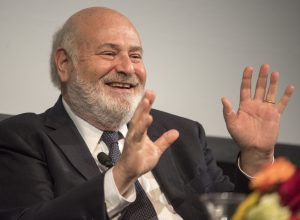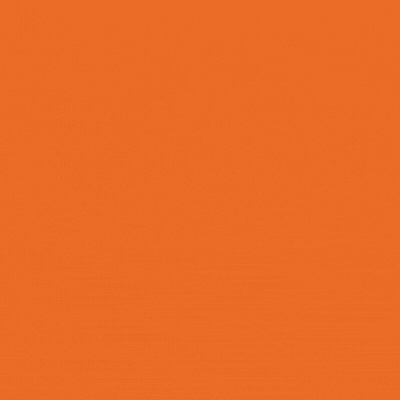In Valle d’Aosta, domenica 28 settembre si vota per le elezioni regionali e comunali. In questo articolo collettivo, vi proponiamo la visione di sei film che raccontano lo sguardo del cinema italiano sulla politica, i politici e il potere nel nostro Paese, dal Nord al Sud, dagli anni ‘70 a oggi.
BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE di Andrea Segre, disponibile su Now
Italia, 2024, drammatico/storico
Berlinguer – La grande ambizione racconta un’Italia di altri tempi, l’Italia del compromesso storico e degli anni di piombo, l’Italia dove circa un terzo degli elettori votava il Partito Comunista di Enrico Berlinguer. In questo senso, il film, oltre a tratteggiare un ritratto del carismatico politico interpretato da Elio Germano, offre uno spaccato di quel periodo storico con le sue speranze in ambito politico e sociale, alcune destinate a rivelarsi illusioni, altre ancora destinate a essere appunto ricordate come grandi ambizioni. Nello specifico, il film si sofferma sui tentativi di accordo tra il PCI e la Democrazia Cristiana di Aldo Moro, nel pieno della Guerra Fredda.
Il racconto si sviluppa con uno stile asciutto e quasi documentaristico, dove alle ricostruzioni si alternano alcuni filmati d’archivio. Segre e Germano restituiscono di Berlinguer l’immagine di un uomo dai solidi principi morali, di un padre di famiglia molto umano e, soprattutto, di un politico da cui molti Italiani si sentivano rappresentati. Nel film, si pone particolare enfasi su questa dimensione popolare, in special modo attraverso le scene dei comizi dove Berlinguer parla a una folla punteggiata di rosso. Al di là della riflessione politica e storica, questo è l’aspetto che maggiormente rimane di Berlinguer – La grande ambizione, ovvero la fotografia di un’Italia in cui la politica riusciva ad appassionare un gran numero di cittadini, riusciva a farli sentire parte di qualcosa di più grande.
LORO 1 e LORO 2, di Paolo Sorrentino
Italia, drammatico, satirico, 2018

Prima, appare come immagine: è un tatuaggio che marchia il fondoschiena di una ragazza. Poi, è parola orale e scritta (LUI) che orienta i discorsi e accende lo schermo di un cellulare. Infine, è corpo e voce femminile, maschera sorridente truccata da odalisca. È attraverso forme suppletive di presenza che viene presentato Silvio Berlusconi nella prima parte di “Loro 1” di Paolo Sorrentino: l’uomo di potere, fuori campo e fuori fuoco, è icona simbolica, illuminazione schermica e travestimento giocoso. La sua assenza è il centro magnetico attorno cui ruotano loro, come pianeti attorno al sole che, in un falso movimento (si spostano sempre, senza andare da nessuna parte), aspettano di essere illuminati dalla luce dei suoi raggi.
Durante l’intero film, Silvio Berlusconi si fa altro da sé e la camaleontica assunzione di apparenze molteplici diviene il tratto distintivo della sua messinscena. L’unica cosa che importa, come dice al nipote, è essere creduti. E se la mentalità media del pubblico italiano – spirato intellettualmente come quella pecora che, per sineddoche, rappresenta il gregge umano – è quella di uno studente che non siede nemmeno nei primi banchi, il gioco manipolatorio della verità è ancora più semplice.
In “Loro 2”. il vero protagonista è lui, in una caleidoscopica moltiplicazione della propria presenza. Nel campo-controcampo che apre il film, Toni Servillo interpreta sia Silvio Berlusconi, sia Ennio Doris, come se l’ego ipertrofico dell’uomo di potere potesse vedere nell’altro da sé sempre e solo una conferma positiva di se stesso. Silvio diventa Augusto Pallotta quando vende telefonicamente un sogno e promette una vita che può farsi fiction televisiva. La cancellazione di ogni differenza tra reale e finzionale è la strategia persuasiva per continuare a vivere senza rivelarsi. È in questa logica che l’altruismo è il miglior modo per essere egoisti. È in base a questa coincidenza di significati che i brandelli di spazzatura possono tramutarsi in pillole di mdma e che la cacca pestata potrebbe essere terriccio, ma anche qualsiasi altra cosa. L’irruzione del reale (lo sporco e il fetore) può sempre essere sospesa in ralenti nelle forme immaginarie dell’apparire e tramutarsi in onda pervasiva anestetizzante e disinibente.
Non è un caso che due riferimenti letterari presenti nel film guardino all’universo narrativo di José Saramago: se L’uomo duplicato si fa primissimo piano che demistifica l’unicità identitaria dell’essere umano, Cecità è il campo lunghissimo che inquadra quell’epidemia trentennale di egoismo e narcisismo che ha appannato i loro (ma anche i nostri) sguardi. Ennio Doris dice che nessuno cambia e che nessuno è in grado di uscire da se stesso. Veronica Lario accusa il marito di essere una lunghissima e ininterrotta messinscena.
La vita come fiction, intrappolata nella ragnatela del gioco delle parti, è eterno ritorno dell’uguale, camuffamento dell’identico che è destinato a perdere il proprio incanto per accartocciarsi nella ripetizione di un patetico disincanto. Un po’ come quel vulcano artificiale che, alla fine, dopo tante promesse, erutta: l’unico a ammirare e a specchiarsi in quel getto, spettacolare, ma finto, è lui. Rimasto ormai solo, in un primo piano che lo mostra con più capelli e più cerone che mai. Eternamente sorridente, come da copione.
TODO MODO di Elio Petri, disponibile su Internet Archive
Italia, 1976, drammatico/grottesco
In un grande albergo sotterraneo adibito a ritiro spirituale, uomini di potere si raccolgono sotto la guida di un sacerdote per tre giorni di esercizi, confessioni e penitenze. L’intento dichiarato è quello di purificarsi, ma fin dall’inizio il rituale si rivela un pretesto: la preghiera diventa teatro, la confessione una recita, la penitenza un’esibizione. Il Presidente, figura carismatica e sfuggente, domina la scena incarnando l’ambiguità del potere. La chiusura claustrofobica della struttura rende palpabile un’atmosfera di sospensione, in cui ogni gesto appare carico di sospetto e di ipocrisia.
All’esterno, una misteriosa epidemia dilaga, mietendo vittime invisibili. Questo elemento, che resta sullo sfondo, agisce però come contrappunto e minaccia costante: mentre fuori si muore, dentro i potenti recitano il loro rituale di espiazione senza riuscire a guardare davvero la realtà. La pandemia non è tanto un dato narrativo quanto una metafora: ricorda che il mondo procede al di là delle mura chiuse, e che la politica autoreferenziale, ripiegata su se stessa, non riesce più a rispondere ai bisogni concreti della collettività.
Elio Petri costruisce con Todo modo una parabola sul potere come finzione perpetua, un sistema che si alimenta dei propri simboli e che, nel momento in cui cerca la salvezza, rivela la propria natura autodistruttiva. Il grottesco, l’insistenza sui riti, i corpi rinchiusi negli interni bui, tutto concorre a trasformare la vicenda in una rappresentazione allegorica, dove religione e politica si confondono in un unico linguaggio di dominio.
LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE di Pif, disponibile su Netflix
Italia, 2013, giallo,drammatico,commedia

Mafia: una parola che da sempre incute timore a tutti, ma non al piccolo Arturo, che vive con la priorità di conquistare Flora, la compagna di classe delle elementari. Con i suoi occhi innocenti e ingenui, il protagonista diventa spettatore e narratore di una violenza crudele che si fa sempre più strada nella Palermo degli anni ‘70/80.
Il regista usa una storia d’amore elementare come pretesto per raccontare i crimini commessi da Cosa Nostra e dell’intreccio politico-mafioso che da sempre caratterizza l’organizzazione. La politica locale e lo stato sono inermi dinanzi a omicidi compiuti a sangue freddo; la parola Mafia diviene a tutti gli effetti un tabù di cui è meglio non parlare per evitare problemi.
Pif sfrutta il mezzo cinema con il duplice intento di divertire grazie alla leggera storia d’amore tra Arturo e Flora e di documentare fatti di cronaca nera, per fare in modo che rimanga la memoria di chi è morto combattendo la criminalità organizzata.
Nonostante il film presenti una struttura semplice, lo spettatore viene completamente immerso in una storia fatta di speranza, ma anche rassegnazione. “La mafia uccide solo d’estate” è una piccola commedia capace di far divertire, ma soprattutto di non far dimenticare ciò che la Mafia è stata capace di fare.
IL CAIMANO di Nanni Moretti, disponibile su Disney+
Italia, 2006, commedia

Storia di un film impossibile: Teresa (Jasmine Trinca) si affida a Bruno (Silvio Orlando), produttore in crisi specializzato in cinema trash, per dare vita a un progetto su un imprenditore miliardario che fonda un partito e diventa capo del governo, tra corruzione e svolte conservatrici. Nessun riferimento a qualche “Cavaliere” è puramente casuale. Nell’intreccio tra arte e vita intrinseco nella sua poetica, il film di Moretti segue, in fieri, le peripezie di una produzione rischiosa: nessuno vuole recitare in un film chiaramente ispirato al potere di Berlusconi, né tantomeno finanziarlo o far parte della troupe. Così, dodici anni prima di Sorrentino, Teresa e Bruno si aggirano tra frammenti di set non finiti e maschere grottesche. Ma da questo puzzle di volti e attori che tentano di recitare una parte, emergono le diverse facce del politico camaleontico: la caricatura di sé stesso, la restituzione pseudorealistica della persona pubblica, l’immagine oscura e per certi versi noir del disfacimento (ben più che morale) di una nazione su cui il film, non a caso, decide di concludersi, con l’esemplare finale fantapolitico forse non così distante dalla “realtà”. Perché in fondo Moretti, come già in Aprile, è interessato non tanto all’uomo-Berlusconi, ma alla fenomenologia del berlusconismo, alla regressione di un intero Paese nella società dei consumi più dozzinali, tra glorificazione dei valori di destra e cervelli spenti davanti ai teleschermi di Mediaset. Ma questo era solo l’inizio.