Finalista al premio letterario della Valle d’Aosta con “Miss Italia” (La Nave di Teseo), Claudia Durastanti è una scrittrice e traduttrice nata a Brooklyn nel 1984 da una famiglia originaria della Basilicata. La sua biografia è segnata dalle migrazioni. Dopo aver vissuto a lungo in Basilicata, si è trasferita a Londra, dove ha vissuto per nove anni e fondato il Festival of Italian Literature. Come scrittrice ha esordito nel 2010 con il romanzo Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra, vincitore del Premio Mondello Giovani. Il suo libro più noto, La straniera (2019), è stato finalista al Premio Strega.
Il titolo “Missitalia” evoca subito un immaginario forte e stratificato. A cosa si deve questa scelta e in che modo anticipa i temi del romanzo?
Da un po’ di tempo mi capita di lavorare con dei titoli “predittivi”. Era successo già con La straniera, dove è stato il titolo a generare una forma del racconto e anche con Missitalia, che inizialmente si chiamava La malalingua. È chiaro che se fossi andata avanti con quel titolo ne sarebbe discesa una narrazione diversa, magari con la stessa ambientazione e gli stessi personaggi, ma con un’impostazione da romanzo storico e di discorso sulla questione meridionale più tradizionale, in cui la dimensione subalterna è più riconoscibile e romanticizzata. Missitalia è invece allo stesso tempo un titolo composto – ha l’ambizione di inventare un sentimento, in cui la nostalgia di un paese che sta per farsi è contestuale proprio alla sua nascita, in quanto contiene già un’idea di alternativa perduta, è la nostalgia di tutto portata dalla giovinezza – ma anche “sfasciato”, poiché gioca a scomporre i motivi del romanzo post-risorgimentale classico.
Il libro si muove su tre registri narrativi, tre tempi e più voci femminili. Qual è stata la sfida maggiore nel tenere insieme queste traiettorie e farle dialogare tra loro?
Fare in modo che queste donne potessero essere la stessa donna scritta da tre autrici diverse, e viceversa: tre donne diverse scritte dalla stessa autrice. Quale impressione prevale? Volevo che fossero tre donne autonome. Per garantire a ognuna un percorso interrelato ma riconoscibile, ho dovuto viaggiare nel tempo, cambiare stile, sottrarle a un’idea convenzionale di genealogia e sorellanza e far sì che per loro l’amore contasse tanto quanto la visione della storia e del progresso. Renderle dei personaggi non solo funzionali a una trama, ma con una precisa visione poetica, è stata la sfida più bella e interessante per me.
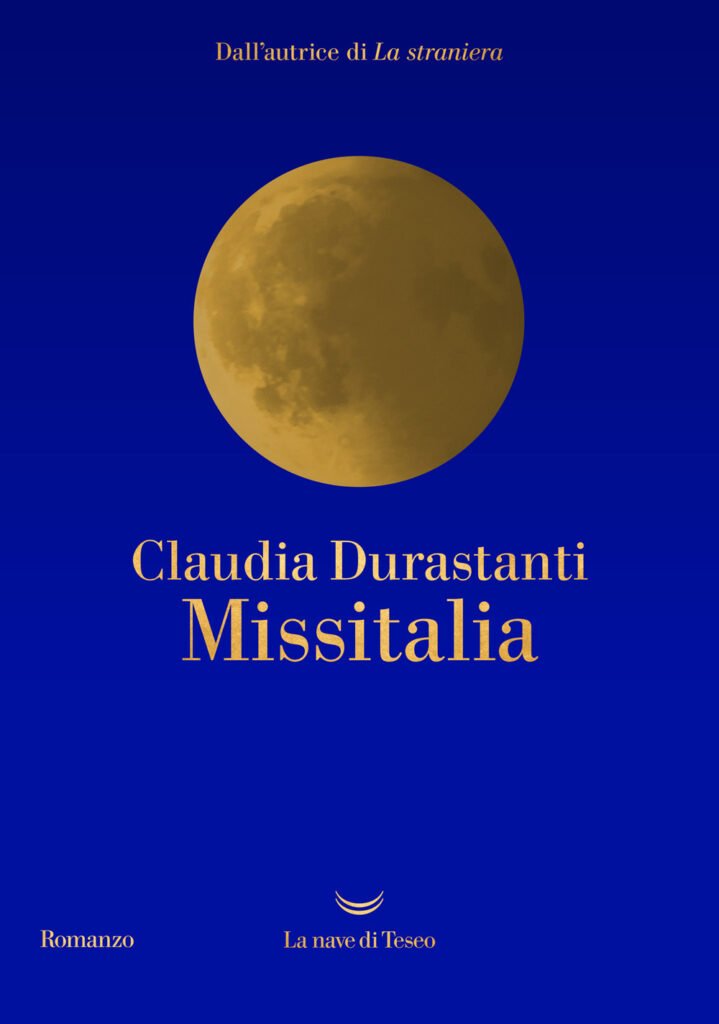
Il Sud, nel romanzo, appare come un luogo insieme concreto e simbolico. È più una geografia reale o una condizione dell’anima?
Direi una specie di animismo geografico, in cui prima il territorio forma il carattere e la visione di chi ci abita, e poi diventa in sé carattere e visione, e soprattutto non viene mai definito come tale, perché è totalmente connaturato alla vita dei personaggi che lo abitano. Ma è un Sud parziale, volutamente parallelo, metaforico e minore, che vuole sfuggire alle grandi aggregazioni identitarie che mi mettono sempre a disagio. È un Sud che sfugge al labirinto delle somiglianze, all’idea che la felicità meridionale, quando esiste, sia sempre un’eccezione, mentre l’infelicità meridionale si somigli sempre. Un po’ il contrario dell’assunto di Tolstoj. Ed è un Sud che si difende senza ricorrere alle solite armi. Almeno era questa l’aspirazione.
Chi è davvero Amalia Spada? Una madre mitica, una figura allegorica, o un simbolo preciso dell’esperienza femminile nel Mezzogiorno italiano?
È la madre ideale, perché è quella che impartisce l’insegnamento più importante: imparare a lasciare andare. E infatti A, nella terza parte, è l’unica figlia ideale, lontana nello spazio e nel tempo, che la ascolta e riesce a completare la sua esperienza di lutto come se fosse una meraviglia, una reinvenzione di sé. Per me Amalia Spada è un personaggio iper-materno, perché accoglie in sé questa capacità di accudire e rendere libere allo stesso tempo, che è un po’ un riflesso del mio rapporto con la Val d’Agri, e cosa è stato il Sud per me, dopo esserci cresciuta dai 6 ai 19 anni. Me ne sono andata, ma riconosco la sua matrice.
Ada sembra attraversare la Storia più che parteciparvi. È il destino di chi arriva dopo, o è una forma di resistenza silenziosa?
Ad Ada ho forse affidato il compito più difficile, quello di cambiare le proporzioni alla storia: ricordo con fascinazione quando gli anni di piombo ci venivano proposti come l’esito di grandi disegni, di direzioni ben mirate della storia, e il crescente disagio con cui poi molto si riduceva a microstorie collettive, ambigue e sovrapposte. Non vale solo per quel periodo storico, ma giocando di anticipazione, è mai possibile che una ragazza come Ada – centralinista più che stragista – possa aver innescato qualcosa di paradossale e di ridicolo, rispetto alle grandi idee con cui leggiamo il tempo? Non so se è resistenza, a suo modo si porta addosso una grande responsabilità narrativa nell’indurre questo sospetto.
Nel tuo romanzo il ritorno assume un significato profondo: si può davvero tornare, oppure si torna sempre “altra”, come A quando lascia la Luna per la Terra?
Si torna sempre per ricongiungersi con un ologramma di sé che ci siamo lasciati alle spalle o per sfrattare il fantasma che ha occupato il nostro posto. Ologrammi o fantasmi: quello che ritroviamo dipende dal nostro senso di fiducia in quel dato momento, ma è molto più probabile che si scambino le parti, finché non occupiamo di nuovo un posto con tutto il corpo. Un corpo inedito, proprio perché tanto segnato dal viaggio.










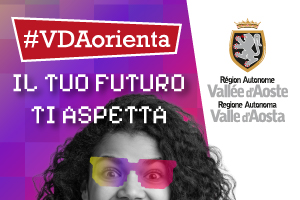

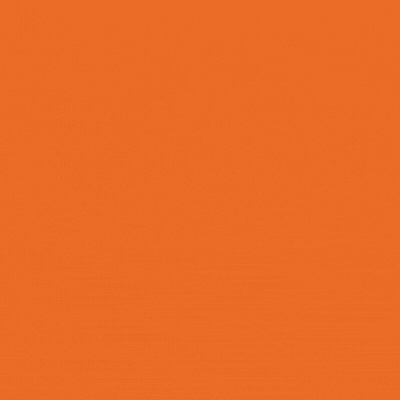

Una risposta
Libro noiosissimo e per niente scorrevole