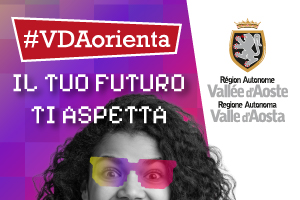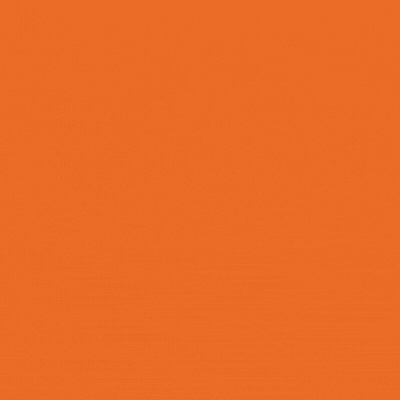Docente presso la Holden Academy, Dario Voltolini (Torino, 1959) è autore di racconti, romanzi, radiodrammi, testi di canzoni e libretti per il teatro musicale. Al Premio Letterario della Valle d’Aosta è nella terna dei finalisti con Invernale (La Nave di Teseo), libro incluso nella sestina del Premio Strega 2024, finalista anche all’Orbetello Book Prize e al Premio Flaiano.
Fra le sue pubblicazioni: Una intuizione metropolitana (1990), Rincorse (1994), Forme d’onda (1996), 10 (2000), Primaverile (2001), I confini di Torino (2003), Sotto i cieli d’Italia (2004, con Giulio Mozzi), Le scimmie sono inavvertitamente uscite dalla gabbia (2006), Foravìa (2010), Pacific Palisades (2017), Sedici passeggiate con Kuma (2023), Imaginations (2024). Ha scritto libretti per Nicola Campogrande e il testo della canzone Queste ferite sono verdi (2013) per L’Orage, vincitrice di Musicultura. Nel 2022 ha pubblicato Il Giardino degli Aranci.
Ha scritto Invernale tutto d’un fiato. Com’è stato lasciarsi andare così alla scrittura?
Sono state più o meno sette settimane di concentrazione pressoché quotidiana. Ho cominciato a scriverlo in Italia e ho finito all’estero senza che lo spostamento abbia influenzato la stesura, che ho fatto senza montaggi, cioè “buona la prima”, come si dice nel cinema. È stata un’esperienza molto interessante. Spedivo per mail i file uno dopo l’altro a mia figlia Evelina, che li leggeva e mi spronava a continuare.
Quanto è stato difficile scrivere una storia così personale senza lasciarsi travolgere dalle emozioni?
Paradossalmente non è stato per nulla difficile dal punto di vista delle emozioni, anzi, più le rivisitavo a fondo nel ricordo, più era semplice tradurle nella scrittura.
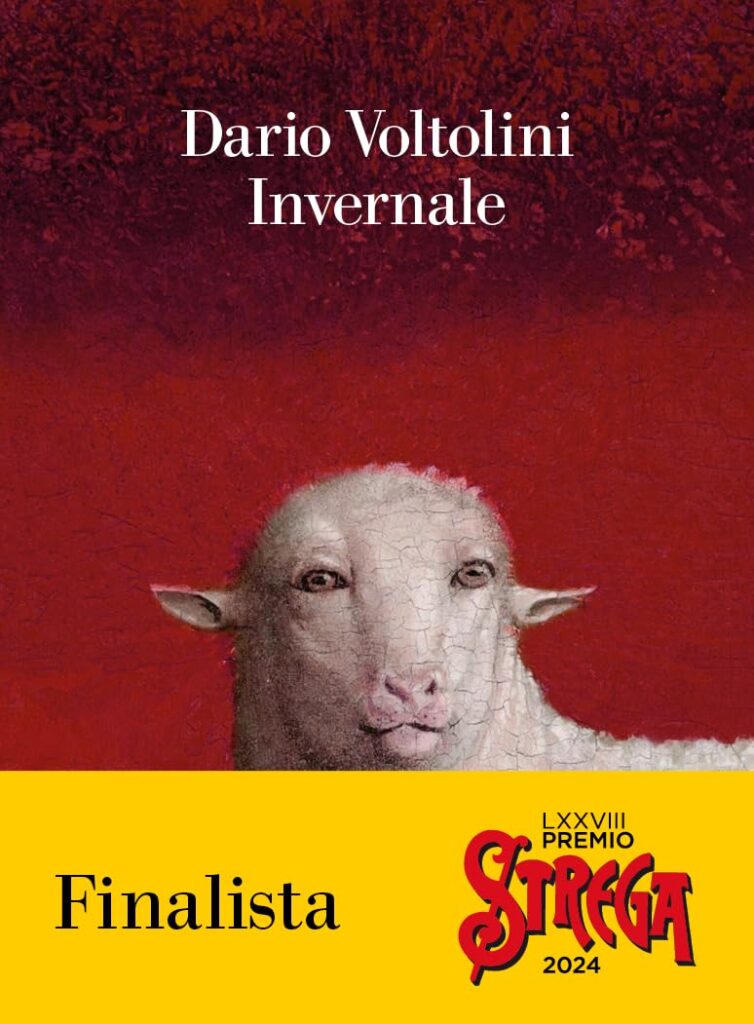
Il libro inizia con scene molto forti, quasi crude. Era il suo modo per entrare subito nel cuore della storia?
A me piace, come lettore, quando un racconto mi fa entrare immediatamente nella scena, e quindi ho cercato di fare così anche come scrittore per chi avrebbe letto il libro: è una scena di lavoro di mio padre al mercato di Porta Palazzo nel momento di massimo affollamento, un sabato degli anni 70. Ho cercato di sfruttare la mia conoscenza diretta di quell’attività per renderla al meglio con le parole. Non ci ho pensato nemmeno un secondo, sentivo che dovevo come minimo provarci. La prima volta che mi sono sentito immediatamente trasferito all’interno della scena in un libro è stata un’esperienza forte come lettore e in qualche modo è riemersa quando poi mi sono messo a scrivere anche io, tanti anni dopo. È il primo capitolo di “Conversazione nella Cattedrale” di Mario Vargas Llosa. Riporto qui il primo capoverso: “Dalla porta de «La Crónica» Santiago guarda l’avenida Tacna, senza amore: automobili, edifici disuguali e scoloriti, scheletri di pubblicità luminosa che ondeggiano nella nebbiolina, il mezzogiorno grigio. In che momento si era fottuto il Perù? Gli strilloni, infilandosi tra i veicoli fermi al semaforo della calle Wilson, gridano i titoli dei giornali del pomeriggio, e lui comincia a camminare, piano, verso la Colmena”. Torino-Lima in 0 secondi!
Il suo papà nel libro sembra una persona molto concreta, forte, silenziosa. È proprio come lo ricorda?
Sì, molto concreto e forte, sia fisicamente sia caratterialmente. Una forza per nulla aggressiva. Aveva tratti di gentilezza ed eleganza innati. Silenzioso direi di no: era molto riservato sulle sue emozioni, sull’espressione dei suoi pensieri. Ma, al contrario, aveva una parlantina rapida, umoristica, brillante, sagace. Sul lavoro soprattutto. Ricordo il mercato di quegli anni come una bolgia piena di vita dove tutti i commercianti si lanciavano battute da un banco all’altro in continuazione, senza mai perdere il ritmo del lavoro.
C’è un ritmo particolare nel libro, quasi come se ogni parola avesse un suo peso. Ha lavorato tanto sullo stile?
Credo di aver lavorato praticamente solo sullo stile, o meglio sulla lingua, ma intendo dire negli anni (il primo libro l’ho pubblicato nel 1990), non solo per questo libro. Un po’ come se avessi fatto un lungo allenamento. Che tra l’altro continua. È così che vanno le cose per chi scrive. Non è che si diventa necessariamente più bravi, è che per forza si conosce sempre meglio lo strumento che si suona, il quale rivela ogni volta qualche lato nuovo.
Cosa spera che le persone si portino a casa leggendo Invernale?
Ho incontrato con questo libro molte più persone che lo avevano letto di quanto mi sia capitato solitamente con gli altri miei libri e con sorpresa e commozione mi sono sentito dire da uomini e donne che avevano vissuto storie simili, spesso anche molto giovani, che la lettura del mio libro era stata per loro di conforto, di compagnia. Dopo averlo scritto temevo al contrario che potesse essere un libro che riapriva delle ferite, dei traumi. Che sia accaduto l’opposto è stata una cosa addirittura insperata. Ecco, spero che continui a essere così. A livello di battuta, spero che possa piacere almeno un po’ anche ai vegani!
Se potesse far leggere questo libro a suo padre, che reazione si immagina avrebbe?
Non saprei. Era imprevedibile. Ma sarebbe un’emozione di immensa felicità se mi dicesse “La partita era molto complicata, ma l’abbiamo portata a casa senza prendere neanche un gol”.