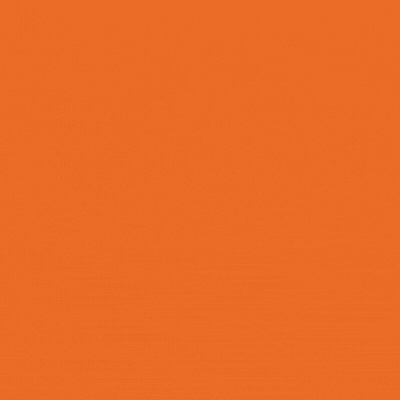Chissà quale sarebbe stata la reazione di Giovanni Agnelli nell’osservare i dati del mercato dell’auto in Italia. Negli anni settanta del secolo scorso, il settanta per cento del parco circolante era Fiat. Che contava su una gamma che copriva l’universo dei segmenti e andava dalla 126 alla 130, passando per la 131 e la 132, per tacere della Campagnola. La Lancia vantava modelli come la Fulvia, la Flavia, poi la Beta, la Gamma, la Delta. L’Alfa Romeo, allora di proprietà dell’IRI, si difendeva bene. E sopravvivevano Innocenti e Autobianchi, quest’ultima soprattutto grazie alla A112. Oggi, la quota di mercato di Fiat è al 12.3 per cento e i modelli sono cinque: Panda, 500 variamente declinata, 600, Tipo e Doblò.
Lancia è sopravvissuta alla sparizione in virtù del grande e permanente successo della Ypsilon, Alfa Romeo, tenuto conto della natura del brand, si difende un po’ meglio con Giulia, Junior, Tonale e Stelvio. Uno stabilimento storico come Mirafiori vive stop di produzione. Il mondo è cambiato, certo, e quello dell’auto ha registrato un trend di mutamenti vorticosi. La concorrenza, a livello europeo e mondiale, è cresciuta in termini esponenziali. La Cina, ad esempio, è sempre più vicina, mutuando un motto di decenni fa. Con un ruolo da protagonista, prima come sede di delocalizzazione dei marchi occidentali, ora come produttrice in proprio con Case quali Byd, Dongfeng, Aiways. Leapmotor e Stellantis hanno stretto una partnership.
L’Europa risponde con l’imposizione di dazi, per tutelare la produzione autoctona, mossa comprensibile ma a rischio di corrispondenti misure da parte di una potenza che detiene il quasi monopolio delle terre rare indispensabili per l’elettrificazione e non solo. Da ultimo, una delocalizzazione all’inverso, dalla Cina all’Europa, con lo scopo, tra gli altri, di evitare i dazi. In un contesto complicato, la politica industriale generale nel nostro Paese vive una sorta di corto circuito: come ha acutamente rilevato Ferruccio De Bortoli, da una parte si invocano investimenti esteri, dall’altra si paventa l’esercizio del Golden Power, quello strumento che un governo nazionale può mettere in campo per condizionare o limitare fortemente gli investimenti medesimi.
A monte di tutto, la produttività che ristagna sostanzialmente da una ventina di anni e le retribuzioni che hanno significativamente perso potere di acquisto. Insomma, da tempo pare che manchi una visione di sistema, anche sul futuro dell’automobile, un settore tradizionalmente trainante. Lanciando una suggestione (provocazione?), perché non pensare a una sorta di Stati generali dell’auto, con la partecipazione della politica e delle parti sociali, insieme a stakeholders, non solo per l’automobile in senso stretto ma per l’intero comparto automotive? Sarebbe l’occasione per decidere se il settore sia da considerarsi ancora nevralgico o meno. E di trarne le necessarie conseguenze.