Il cinema di David Lynch è un’esperienza sensoriale attraverso continui ingressi, dalla soglia sempre mobile. Un limbo instabile in cui le forme diventano informi, subiscono passaggi di stato, evaporazioni e condensazioni alchemiche tra mondi (come Jean Epstein), tra immagine e immaginazione, conscio e inconscio, in un’inestricabilità che investe non solo la narrazione, ma la consistenza stessa delle immagini, materiche e tangibili (penetrabili, come i primi piani di INLAND EMPIRE). Prima di essere, le sue (audio)visioni esistono e accadono. Non a caso i suoi film, specie Strade perdute, sono stati paragonati al nastro di Moebius, paradosso escheriano del disorientamento infinito. Perché nei suoi capolavori “perdersi è meraviglioso”.
Sì, è stato davvero meraviglioso perdersi nelle sue thinking rooms (dal nome di una sua opera al Salone del Mobile del 2024). I suoi film andrebbero fruiti come chiavi di accesso a stanze da visitare, anche quando queste stanze non ci sono o c’è un rifiuto esplicito di varcarne l’ingresso (il finale di Una storia vera è l’altra faccia della medaglia di tutte le sue opere): la loggia nera di Twin Peaks, la scatola-enigma di Mulholland Drive, la casa di Dorothy in Velluto blu, le perturbanti abitazioni postindustriali di Eraserhead, le infinite stanze di Twin Peaks: the return, opera monstrum che è tutta fatta di thinking rooms, non solo per pensare, ma pensanti. Ha osato farci entrare nell’impero della mente, ha generato anticamere dell’inconscio e sovvertito i ruoli di potere tra i sensi di vista e udito, con l’immagine sempre sul punto di smaterializzarsi in dissolvenze, mentre il suono rimane stabile.
Non solo è stato il più grande e istintivo artista del terzo millennio fino ad oggi, ma un autore che ha attraversato indenne quasi 50 anni di storia del cinema (specie nell’epoca dei post: post-moderno, post-surrealista, post-reale), ha sperimentato indenne tutte le forme artistiche possibili come solo i veri geni sanno fare. Ora resta ancora vivo nei nostri sogni, perché solo il cinema, della stessa materia di cui sono fatti i sogni, può preservarlo dalla seconda morte. Improvvisamente lo schermo vacilla: da una nube di vapore compaiono grandi tende rosse, su un pavimento zigzagante. Un omino in giacca e cravatta sbuca da una fessura, con il suo bizzarro ciuffo bianco e la sigaretta in bocca. È David, che sussurra tranquillo nelle nostre orecchie una promessa rassicurante: “ci rivedremo tra 25 anni”.
TWIN PEAKS, 1990-2017, disponibile su Paramount+
Dopo più di 20 anni, la domanda “chi ha ucciso Laura Palmer?” echeggia ancora nella mente dei telefili. Il tormentone al centro della serie di David Lynch ha navigato lungo i decenni, gli stili, le forme dell’immagine e dell’immaginario, ma soprattutto ha cambiato definitivamente le regole del gioco seriale. Là dove c’erano la sit-com e la soap-opera, il poliziesco e il procedurale, il linguaggio visivo netto, quadrato, chiaro e spesso didascalico di racconti che iniziavano e finivano nell’arco di tre quarti d’ora, ora – o meglio, nel 1990 – c’è una storia complessa e oscura, uno stile visionario e inquieto, un uso delle immagini ambiguo e stimolante, un racconto che è soprattutto un viaggio metafisico.

Lynch definisce una volta per tutte lo status di cult tv, con personaggi bizzarri al limite dell’auto-parodia e atmosfere che hanno turbato le notti di milioni di spettatori, rivoluzionarie perché senza definizione e soluzione, arrivando all’incredibile terza stagione del 2017 (da qualcuno definita revival) a superare gli steccati dei linguaggi artistici, approdando all’arte concettuale e alla pittura in movimento. Imprescindibile.
VELLUTO BLU, 1986, disponibile su Apple TV
Il cinema di Lynch è dreamlike (sognante), non è semplicemente un sogno. Forse è stato il regista più istintivo di tutti (Francis Bacon insegna), perché i suoi film sembrano provenire direttamente dall’inconscio, senza il filtro della coscienza, che vela i contenuti latenti troppo forti per manifestarsi. Il metodo trascendentale con cui dà vita alle sue visioni rispecchia il lavoro onirico e i suoi film sono così alogici e irrazionali non perché Lynch decidesse a priori di renderli tali, ma in quanto seguiva il flusso della mente. Le sue opere sono avventure ermeneutiche che hanno coinvolto innumerevoli teorici e psicanalisti, autori di analisi testuali per rivelare l’isomorfismo tra il suo cinema e la psiche. Proprio Velluto blu mostra alcune condizioni fondamentali dell’esperienza spettatoriale (voyeurismo e scena primaria), ma è anche un percorso edipico: uccidere il Nome-del-Padre per salvare la Madre.

In un certo senso il padre è il cinema classico, che Lynch ripensa adottandone linguaggio, valori e miti, ma per sovvertirli dall’interno. Un’operazione postmoderna, manipolazione espressiva che mira però ad essere conoscitiva: usa le forme narrative stabilizzate per ribaltarle in modo perturbante ed esprimere qualcosa di non-segreto. I suoi incubi esplicitano tutto ciò che nel noir e nell’epoca d’oro di Hollywood era implicito. Bastano i primi due minuti del film per scrivere e riscrivere la Storia del cinema: attraverso una serie di dissolvenze incrociate in ordine a-cronologico, si dà l’idea di un tipico quartiere suburbano americano. In superficie vediamo fiori curati, sorrisi e praticelli; nel sottosuolo, invece, si contorcono insetti osceni sopra orecchie mozzate. Di queste oscurità perlustrate dalla macchina da presa ne abbiamo parlato in un articolo di qualche mese fa: clicca qui per approfondire la dark side dell’american dream.
MULHOLLAND DRIVE, 2001, disponibile su Prime video
Con Mulholland Drive, Lynch ci proietta in un labirinto onirico. Il film si apre con un incidente stradale su Mulholland Drive, la celebre strada di Los Angeles: una donna (Laura Harring) sopravvive miracolosamente, perdendo però la memoria. Si rifugia, quindi, in una casa apparentemente abbandonata. Qui incontra Betty Elms (Naomi Watts), un’aspirante attrice appena arrivata a Hollywood che, spinta dalla curiosità, inizia ad aiutare la sconosciuta a scoprire la sua identità. Ma scena dopo scena la narrazione si sgretola, sogno e realtà si intrecciano, per indagare l’ambiguità dell’ambizione, del fallimento e del desiderio. Ancora una volta, Lynch fa emergere la sua poetica, caricando di tensione ogni dettaglio, dal sound design alla scelta delle inquadrature. A questo effetto contribuisce anche il direttore della fotografia, Peter Deming, che alterna la luminosità onirica del primo atto alle ombre inquietanti della seconda metà, dove il mondo patinato di Hollywood svela il suo lato oscuro e la fabbrica dei sogni si decostruisce.

Proprio una scena del film, quella del Club Silencio, costituisce una sorta di manifesto estetico: la canzone Llorando, cantata in playback, rappresenta il senso di illusione e perdita che pervade l’opera. La riflessione di Lynch sul dualismo tra identità e realtà, già iniziata in Lost Highway, ricorre qui a tratti in modo schizofrenico, con personaggi che si rivelano sempre più ambigui e oscuri. Mulholland Drive nasce in realtà come episodio pilota per una serie TV, poi rifiutata da ABC. Allora Lynch, insoddisfatto della decisione, scelse di trasformare il progetto in un film e nei mesi successivi girò nuove scene: probabilmente anche per questo la struttura dell’opera si sviluppa in modo volutamente ambiguo.
UNA STORIA VERA, 1999, disponibile su The Filmclub
David Lynch ci ha lasciati, e con lui un’idea di cinema che sapeva esplorare il mistero del quotidiano con la potenza di un sogno. Nel ricordarlo, viene spontaneo tornare a Una storia vera (The Straight Story, 1999), il suo film più atipico e, paradossalmente, uno dei più profondamente lynchiani. La pellicola racconta il viaggio di Alvin Straight, un anziano che, impossibilitato a guidare, percorre centinaia di chilometri su un tagliaerba per ricongiungersi al fratello malato, con cui non parla da anni. Una premessa semplice, quasi banale, che nelle mani di Lynch diventa una meditazione sulla vecchiaia, sul tempo e sulla necessità di sanare le ferite prima che sia troppo tardi.
Qui non ci sono allucinazioni disturbanti o realtà che si sgretolano, ma ogni inquadratura porta il segno inconfondibile della sua poetica: la lentezza ipnotica, gli incontri con personaggi eccentrici che sembrano emergere da un altrove, la malinconia avvolgente che si posa su ogni scena. Richard Farnsworth, nel ruolo di Alvin, regala un’interpretazione silenziosa e struggente, resa ancora più toccante dalla malattia che lo stava consumando lentamente. E poi c’è la natura, vastissima, quasi metafisica, ripresa con una semplicità che sfiora il trascendente. A rendere il viaggio ancora più struggente è la colonna sonora di Angelo Badalamenti, che qui abbandona le inquietanti atmosfere elettroniche tipiche delle sue collaborazioni con Lynch per lasciarsi andare a melodie folk e minimaliste, evocando il silenzioso scorrere del tempo e la solitudine del protagonista. Se Lynch ha sempre esplorato il lato oscuro dell’America, qui ne cattura l’anima più dolce e fragile, ricordandoci che il viaggio più straordinario è spesso quello che ci riporta a casa.
WHAT DID JACK DO?, 2017, disponibile su Netflix
In questo assurdo cortometraggio, un detective (interpretato da Lynch stesso) si trova in un bar di una stazione immaginaria per interrogare una scimmia cappuccina accusata di omicidio. La scimmia, di origini proletarie (e ovviamente parlante), cerca di provare la sua innocenza dimostrando come per via delle sue umili origini e della sua razza viene ingiustamente accusata. Non ci sono parole umane per descrivere la bellezza e l’assurdità di questo cortometraggio: 17 minuti di meravigliosa peregrinazione nel mondo di Lynch, un viaggio malinconico e poetico che diverte molto lo spettatore e il regista stesso. Il film è stato presentato nel 2017 durante l’inaugurazione della mostra fotografica firmata dal regista alla fondazione Cartier di Parigi e poi nel 2020, più precisamente il 20 gennaio, giorno del compleanno di Lynch, diffuso su Netflix. Questo cortometraggio è la sintesi perfetta di tutto ciò che rende David Lynch un autore e artista a 360°, un grande genio spinto da un’incredibile passione e amore per il cinema. Ha infatti curato praticamente ogni aspetto del film: ne è stato regista, sceneggiatore, attore principale, montatore, compositore della musica, ha persino costruito lui stesso il set, nello specifico ha creato le sedie su cui i due personaggi sono seduti. Insomma, un’estensione tangibile della sua genialità, una prova d’amore per la settima arte, ma anche e soprattutto una bizzarra dimostrazione del suo peculiare senso dell’umorismo, uno dei pochi grandi geni del cinema capace di non prendersi troppo sul serio. Ci mancherà terribilmente.













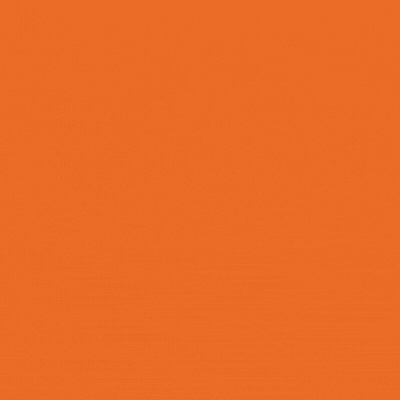

4 risposte
Il più grande regista del terzo millennio è solo uno: Gabriele Muccino
Chi ha scritto questo articolo è amante delle sparate:
“bastano i primi due minuti del film (velluto blu) per scrivere o riscrivere la Storia del cinema”. Nientepopodimeno che.
Oltretutto se il suo cinema è dreamlike e sognante come fa ad essere contemporaneamente istintivo? L’istinto non dorme, è perfettamente sveglio è rapida azione non sogno.
La sagra delle iperboli e delle esagerazioni, vorrei sapere chi ha scritto questo articolo.
Punto 1º: “Linch” si scrive con la Y (basta leggere, se si è in grado di farlo).
Punto 2º: Lynch scrive e ri-scrive la storia del cinema nel senso che, nel pieno del periodo postmoderno, rielabora la storia precedente, rinnovandola e infondendovi un sangue nuovo. Giustamente lei dice che Velluto Blu “sembrava una parodia”: questa è proprio una delle caratteristiche portanti del postmoderno (che non ha nulla di dispregiativo, anzi), cioè dilatare le situazioni fino al parossismo, all’esasperazione farsesca e tragicomica, come certi balletti bizzarri che si ritrovano spesso nelle sue opere nei momenti più violenti.
Punto 3º: se, come lei afferma, l’istinto è sveglio e vigile, sicuramente per girare un film bisogna essere svegli altrimenti o si è sonnambuli, o il film resta tutto nella propria testa (situazione per altro non troppo distante da certi film del Maestro).
Punto 4º: per “dreamlike” si intende una situazione non chiaramente onirica (come alcune scene dei film di Bunuel che sono dichiaratamente delle scene di sogni diegetici), ma che ha le caratteristiche perturbanti e irrazionali di certi sogni, anzi incubi.
Punto 5º: scrivere un articolo è sempre una libertà di espressione, dunque le iperboli sono più che lecite, specialmente nel caso in cui si parla di uno dei registi più importanti del cinema recente. Può non piacere come autore, ma prima di insultare chi ha scritto l’articolo, forse bisognerebbe avere qualche conoscenza in più, o si cade nell’imbarazzo totale con errori come il confondere la i con la y
A parte che definire Linch “il più grande e istintivo artista del terzo millennio” è un’iperbole esagerata, ha fatto film buoni e molto meno.
Tra i pessimi ci metto senza dubbio Velluto blu.
Velluto blu lo avevo visto al cinema, bruttissimo film sembrava una parodia, se non lo era è stato involontariamente una parodia, pure mal recitato. Una presa per il c.
Semmai come film di Linch da rivedere ci metterei the Elephant man. Quello bellissimo e commovente film, ottimamente realizzato.
Velluto blu, una vera… schifezza.