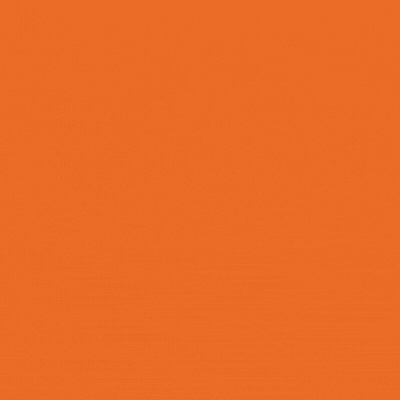Famiglia. A leggere l’interdittiva antimafia emessa lo scorso 13 settembre dal questore Pietro Ostuni nei confronti della C.G.F. Srls, società con sede a Gignod impegnata nell’edilizia e negli autotrasporti, si perde il conto del numero di volte in cui questa parola è usata.
I funzionari della Divisione Polizia anticrimine della Questura che si sono occupati del provvedimento, abituati a pesare ogni singolo vocabolo destinato a finire sulla carta, vi hanno fatto ricorso sia in senso tradizionale, per significare un nucleo di parenti, sia nell’accezione tesa ad indicare l’elemento fondante “a livello particellare” della “struttura clanica” della criminalità organizzata.
Dalle sette pagine a base di date, luoghi e fatti, frutto delle informazioni acquisite da varie forze dell’ordine ed altri organi dello Stato – che Aostasera.it ha avuto modo di consultare – emergono infatti scenari attraversati, assieme od individualmente, da persone con lo stesso cognome, perché appunto legate da (stretti) vincoli parentali.
Vicende che affondano le loro radici nell’Aspromonte dei primi anni novanta, quando la guerra di ‘ndrangheta impazzava nella piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria), mietendo morti ogni mese. La ricostruzione, però, parte dall’oggi, perché recente è la genesi dell’atto con cui il Questore inibisce all’impresa di Gignod di intrattenere rapporti professionali con la Pubblica amministrazione, ritenendola a rischio di infiltrazioni malavitose.
In altre regioni italiane, sottoscrivere un decreto del genere tocca al Prefetto, le cui funzioni vengono assolte in Valle d’Aosta dal Presidente della Regione, ma le competenze antimafia sono tra le poche delegate dallo Stato ad un’altra figura.
Una domanda tra molte
E’ il 18 maggio scorso quando la C.G.F. Srls deposita istanza per l’iscrizione alla “White list”, vale a dire l’elenco delle imprese, istituito da una legge del 2012 contro l’illegalità nella pubblica amministrazione, delle quali è verificata l’estraneità al rischio di inquinamento mafioso e, pertanto, titolate ad operare quali fornitori, prestatori di servizi o esecutori per gli enti e le istituzioni.
Una domanda tra molte: gli iscritti, nell’ultimo aggiornamento disponibile online, sono 177 e nella lista dei richiedenti se ne contano 119. La sottoscrive Michele Furfaro, 28 anni, nato a Polistena (Reggio Calabria) e residente in Valle, amministratore unico dell’azienda. Oltre a rivestire tale ruolo, detiene il 95% delle quote sociali, con il restante 5% nelle mani di suo fratello Romano.
La ditta, in passato, aveva già fatto parte dell’elenco, ma senza rinnovare nei tempi previsti dalla legge l’iscrizione, scaduta il 14 marzo 2017. Iniziata l’istruttoria per la nuova domanda, tuttavia, emerge una “vicenda anomala nella formale struttura dell’impresa”, costituita da una “importante variazione societaria” intervenuta poche settimane prima della richiesta.
In sostanza, Giorgio Furfaro, padre dell’amministratore unico e del socio di minoranza, e all’epoca detentore del 50% delle quote della C.G.F., ne aveva ceduto, a titolo gratuito, il 45% a Michele (salito quindi al 95%) e il 5% a Romano (che ha fatto così il suo ingresso nel capitale sociale). Circostanza che fa accendere più d’una spia sui cruscotti di chi istruisce la pratica.
Anche perché Giorgio è titolare di un’impresa individuale con sede a San Giorgio Morgeto che, il 10 aprile di quest’anno, si è vista respingere dalla prefettura di Reggio Calabria l’istanza di iscrizione alla “White list", con annessa interdizione. Sono le informazioni “acquisite per il tramite delle forze di polizia” del capoluogo calabrese a raccontarne la storia.
Un passato ingombrante
Classe 1960, Giorgio Furfaro ha un passato che incrocia più volte le aule di giustizia. Nel 1982, il tribunale di Livorno lo condanna a 2 mesi di arresto per detenzione illegale di armi e munizioni (fatti per cui verrà riabilitato nel 2002). Nel febbraio 1991, la Corte d’Appello di Milano gli infligge quattro mesi di reclusione per furto in concorso (anche in questo caso, la riabilitazione arriva nel 2002). Nel 2007, al Tribunale di Aosta, incorre due volte in pene per l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali.
A suo carico esistono pure misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale per un anno, nel 1991, dalla quale viene riabilitato nel 1999, e deferimenti all’autorità giudiziaria per omicidio volontario, associazione di tipo mafioso, violazioni delle leggi sulle armi, estorsione, favoreggiamento, furto e violazione delle norme sugli assegni bancari.
L’episodio per cui finisce sulle pagine nazionali di cronaca si verifica tuttavia l’1 ottobre 1991. Quel giorno, in un agguato nella frazione Pagliaforio di San Giorgio Morgeto, viene colpito ad un braccio e finisce “in condizioni che non destano preoccupazioni” all’ospedale di Polistena. Allora aveva 31 anni. Sotto gli stessi colpi di lupara muoiono però suo padre Antonio e suo fratello minore Romano, rispettivamente 52 e 25 anni.
L’obiettivo dei sicari, si scoprirà, era decapitare la cosca dei Furfaro, attiva nel comune da quattromila abitanti ai piedi dell’Aspromonte, che aveva dominato incontrastata fino all’omicidio. Di quella ‘ndrina, di cui Antonio era considerato il capo, si parla in atti giudiziari della Procura di Palmi sin dal 1981, nonché in varie informative dei Carabinieri e della Criminalpol di Reggio Calabria.
A quel tempo, nella zona, era lotta senza quartiere tra malavitosi: in dieci mesi il conto delle vittime aveva raggiunto quota sessanta, un'enormità. I due uccisi sono raccontati dai giornali usciti in quei giorni come “ufficialmente carpentieri, ma in effetti proprietari di alcuni camion e ruspe con i quali effettuavano parecchi lavori per conto terzi”.
Giorgio viene ritenuto dalle forze dell’ordine affiliato alla cosca, storicamente alleata ai Bellocco-Pesce-Piromalli della piana di Gioia Tauro, nonché alle famiglie Raso-Gullace-Albanese di Cittanova, sempre in provincia di Reggio, all’epoca contrapposta al clan Facchineri.
Non solo, secondo quanto si legge in un rapporto del Gruppo Carabinieri Aosta del maggio 2015, che rimanda ad un’annotazione dei colleghi di San Giorgio Morgeto, morto Antonio, a succedergli al vertice – fino al mutare delle geometrie del crimine organizzato calabrese – sono proprio Giorgio e il fratello maggiore, Vincenzo, che al tempo di anni ne aveva trentatré.
Gli altri familiari
Anche di quest’ultimo si parla nell’interdittiva, evocando i suoi trascorsi da sorvegliato speciale, con precedenti a carico. In particolare, il riferimento è a una sentenza del 1985 della Corte d’Appello di Reggio Calabria (diventata irrevocabile un anno dopo), con cui era stato condannato a tre anni e sei mesi, per associazione a delinquere.
Sia nella sua vita, sia in quella di Giorgio, ad un certo punto vi è il trasferimento in Valle d’Aosta, dove non fanno notizia a lungo. Nella cronaca recente il nome di Vincenzo ritorna nell’ottobre 2015, quando la Tra.Mo.Ter di Saint-Christophe diventa la seconda impresa edile della regione ad essere colpita da interdittiva antimafia.
Secondo le valutazioni del Tavolo interforze in quel caso, la società, pur presentando formalmente come amministratrice la figlia Rossella veniva gestita “di fatto” da lui. Gli elementi che avevano condotto al provvedimento erano emersi dall’indagine “Tempus Venit” dei Carabinieri, imperniata sullo smaltimento irregolare dei rifiuti di vari cantieri, tra i quali quello per la realizzazione del parcheggio sotterraneo “Parini” ad Aosta.
Fatti dai quali era scaturito anche un procedimento penale. Vincenzo – come gli altri cinque imputati – finisce assolto, con un verdetto chiesto al giudice dallo stesso Pubblico ministero, dopo la dichiarazione di inutilizzabilità di alcune intercettazioni telefoniche ritenute cruciali per l'accusa. Proprio all’indomani di tale sentenza, durante un’inusuale conferenza stampa in cui il diretto interessato rimane costantemente in silenzio, l’avvocato Carmela Marrapodi, che ne aveva curato la difesa ed era al suo fianco anche nell’incontro con i giornalisti, chiede di “restituire dignità” all’imprenditore e alla figlia, “oltre che riabilitarli e riabilitare, facendola rientrare nel mercato, la società Tramoter”.
L’esame del contesto familiare operata dall’anticrimine si conclude dicendo di Romano, figlio di Giorgio e socio di minoranza della C.G.F.. “Il suo nome – si legge – compare nell’inchiesta ‘Hybris’ della Procura di Torino-Direzione Distrettuale Antimafia, in qualità di appartenente ai ‘Calabria Boys’, ragazzi autori di atti intimidatori e di bullismo, compiuti sottolineando l’appartenenza alla comunità calabrese”. Nella primavera del 2014, inoltre, viene denunciato dai Carabinieri di Nus per lesioni, ma la parte offesa ritira la querela e il Giudice di Pace sentenzia per il “non luogo a procedere”.
Le annotazioni sulla famiglia si concludono segnalando che il 15 luglio 2015, il Gruppo Interforze Antimafia controlla, effettuandovi un “accesso”, un cantiere a La Thule e rileva la presenza di tutte le imprese riconducibili ai Furfaro, cioè C.G.F., Tra.Mo.Ter e quella individuale di Giorgio.
Interessi non solo parentali
Un quadro che porta, citando ancora il provvedimento del Questore, a “tranquillamente affermare che i rapporti della famiglia Furfaro, intesa non solo come ‘nucleo familiare’, ma come ‘gruppo’, non si limitano solamente ad interessi parentali, ma anche e soprattutto a quelli economici/commerciali, elementi assimilabili a quei ‘rapporti di comparaggio’ ove è presente una forma mentis deviata, trovando così terreno fertile per una ‘influenza reciproca’”.
Quest’ultimo concetto è mutuato da una sentenza del 2016 del Consiglio di Stato, per cui sarebbe errato considerare che il parente di un mafioso sia anch’egli implicitamente tale, ma l'organizzazione ha il suo nucleo fondante nella “famiglia” e, in essa, “anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del capofamiglia e dell’associazione”.
Inoltre, ed è stavolta il Tribunale Amministrativo Regionale ad aver sentenziato nel 2012, “quando un nucleo familiare, allargato o meno, è ‘segnato’ dalla sussistenza di precedenti penali che riguardano tutti, o buona parte dei parenti, non è illogico ritenere che l’ambiente familiare sia esso stesso un elemento condizionante le scelte dell’imprenditore incensurato”.
A questi principi si affianca che la C.G.F. ha acquistato un mezzo d’opera dalla Tra.Mo.ter, dopo che la stessa era stata colpita da interdizione, e che Giorgio Furfaro risulta abitare assieme al figlio Romano, ove ha sede legale l’azienda. Ciò configura, in istruttoria, circostanze di coinvolgimento tali da non poter “aprioristicamente escludere un condizionamento nelle valutazioni di indirizzo economico-finanziario e nelle scelte di policy dell’impresa di Gignod”, oltre al potenziale “intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia” costituito dal passaggio di quote da Giorgio ai figli.
Il “no” all’iscrizione in White list
Messi sul tavolo tutti gli elementi informativi raccolti, l’impresa risulta operare quasi esclusivamente in “settori particolarmente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa” e, stando alle visure camerali, è priva di “quegli organi esterni alla ‘famiglia’ preposti alla pianificazione prima e, dopo, al controllo delle scelte aziendali, così da controbilanciare il feedback aziendale”.
Il Gruppo Interforze si riunisce lo scorso agosto e all’unanimità esprime parere negativo sull’accoglimento dell’istanza della C.G.F., ritenendo la ditta “soggetta a potenziali condizionamenti da parte della criminalità organizzata”. Viene successivamente composto lo strutturato provvedimento del questore Ostuni, che ha efficacia interdittiva nei rapporti con la Pubblica amministrazione.
Cos’è l’interdizione?
L’atto emanato nei confronti della C.G.F. impedisce, appunto, alla stessa di lavorare per committenti pubblici, poiché non ritenuta garantita rispetto ai requisiti previsti dalle norme antimafia. Non si tratta però di una patente criminale individuale rilasciata ai destinatari del decreto, perché “il sistema delle cautele antimafia non mira all’accertamento di responsabilità, ma si colloca come forma di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto a cui assumono rilievo fatti e vicende economico-imprenditoriali”. In sostanza, a dover essere provata, per spiccare l’interdizione, non è l’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il pericolo d’ingerenza”.
Questo, perché il tentativo di infiltrazione mafiosa è “concetto di matrice sociologica e non giuridica”. Si presenta “estremamente sfumato e differenziato rispetto all’accertamento operato dal giudice penale”. Le informazioni che il Gruppo Interforze condivide ed esamina, nell’analisi di ogni caso, non devono provare “l’intervenuta occupazione mafiosa”, ma è sufficiente che dalle stesse si desuma “un quadro indiziario che, complessivamente inteso, sia sintomatico del pericolo di un qualsivoglia collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata”.
Sintomi e pericolo che, per il tavolo che riunisce Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Ispettorato del Lavoro e Direzione Investigativa Antimafia, nel caso della C.G.F. di Gignod esistono. Una conclusione a cui i destinatari del provvedimento possono opporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure al Presidente della Repubblica. Ad oggi lo hanno fatto tutte le altre quattro aziende valdostane raggiunte da analoga interdizione, senza però aver mai visto riconosciute le loro ragioni.






![letture per bambini [] letture per bambini []](https://aostasera.it/wp-content/uploads/elementor/thumbs/letture-per-bambini-20241-r3mtg1opp8viy8vk543kfoipyn9cry6xt06izxq7c0.jpg)