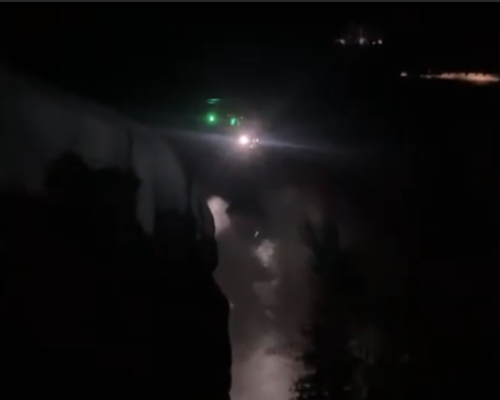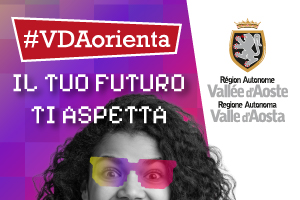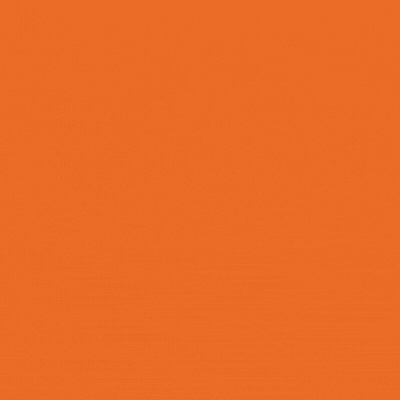Essere vestiti come una frittata, cucire insieme l’estate con l’inverno o avere uno stomaco grande come un paiolo. Modi dire in lingua titsch e töitschu – patrimonio delle comunità walser di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité e Issime – viaggeranno nel mondo. Dalla Svezia alla Norvegia, fino al Giappone.
È il secondo capitolo del progetto “D’Oberteilera chéemen éenger o arrivurun d’greschuneiara?”, portato avanti dall’Università della Valle d’Aosta e dagli studenti delle scuole elementari e medie dei tre comuni dell’alta valle del Lys che con dei disegni e una breve spiegazione hanno illustrato 62 modi di dire caratteristici delle due parlate walser nel loro significato letterale e figurato. L’iniziativa è stata presentata dalle classi e dai loro insegnanti ieri pomeriggio all’auditorium del Palazzetto dello Sport di Gressoney-Saint-Jean durante il convegno organizzato dall’assessorato regionale agli Affari europei per la Giornata internazionale della montagna. Protagonista dell’appuntamento, patrocinato dal Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, è stata la legge del 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche che proprio quest’anno compie 25 anni.
Luogo e ricorrenza si sposano alla perfezione. Nella Valle d’Aosta francoprovenzale, le comunità walser sono una infatti una minoranza nella minoranza e le loro lingue di origine tedesca – il titsch e il töitschu – “stanno vivendo un momento di grande popolarità a livello internazionale – spiega Luisa Giacoma, professoressa dell’Università della Valle d’Aosta e referente del progetto -. Vengono studiate e ritenute interessanti perché sono una testimonianza vivente di stadi precedenti della lingua come se fossero delle antenate del tedesco“. Proprio per questo – dopo aver dato vita ad una mostra e a una pubblicazione – il progetto proseguirà con una collaborazione con alcune scuole della Norvegia e della Svezia e sarà presentato in un convegno in Giappone, a Kyoto, nell’ottobre del 2025.
Gli studenti saranno coinvolti in videoconferenze e scambi culturali con i loro coetanei norvegesi e finlandesi. Inizialmente per comunicare utilizzeranno l’inglese, ma anche qualche parola di titsch delle due Gressoney e di töitschu di Issime visto che “le rispettive lingue per certi versi sono simili”, dice Giacoma. Che aggiunge: “Sono molto contenta perché qui il progetto ha trovato un terreno molto fertile. I modi di dire sono importanti perché esprimono lo spirito di un popolo, sono preziosi per i contenuti e interessanti dal punto di vista linguistico. Sono gli ambasciatori di una lingua”.
Per l’assessore regionale agli Affari europei, Luciano Caveri, “oggi bisogna fare in modo che il mantenimento dei dialetti germanici della valle del Lys e la conoscenza del tedesco diventino una realtà. Non è solo un omaggio alla cultura ma anche una prospettiva turistica, pensando ad esempio alla straordinaria ricchezza della clientela tedesca che può vedere nel Monte Rosa una posto per le vacanze”.
Impegnato negli anni Novanta come deputato nell’elaborazione della legge che tutela le minoranze linguistiche, nel suo intervento Caveri ripercorre l’iter che ha portato all’approvazione della norma. “Questa legge nasce da quella parte iniziale della Costituzione in cui si affermano come dei chiodi piantati in profondità i diritti e i doveri che riguardano i cittadini e l’Italia. Si sono dovuti aspettare cinquant’anni affinché questa si concretizzasse. La tutela delle minoranze è considerata un principio costituzionale e questa è una rete di protezione contro ogni tentativo di attacco nei loro confronti”.
Oltre alla tutela, la legge sulle minoranze linguistiche mette sul piatto “3,5 milioni di euro che dal 2007 vengono riversati sui territori”, spiega l’assessore regionale ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, ricordando che la Valle d’Aosta è una delle regioni più virtuose nell’investirli. “Abbiamo istituito gli sportelli linguistici che possono contare su una rete di oltre 100 collaboratori – C’è un portale online con un dizionario che contiene 103.000 parole con 39 varianti complete di patois. Si registrano 114.000 accessi all’anno con una media di 300 utenti giornalieri”.
“L’obiettivo è di lavorare per alzare l’asticella“, aggiunge il presidente della Regione, Renzo Testolin ricordando che “il 67% della popolazione valdostana capisce e parla il patois o le lingue walser, il 45% li utilizza quotidianamente”. Nel merito, il sindaco di Gressoney-Saint-Jean, Mattia Alliod, sottolinea che la popolazione walser dell’alta valle del Lys – con il titsch e il töitschu – “possiede ancora una competenza attiva della lingua minoritaria”.
“Abbiamo un dizionario in titsch e töitschu e una grammatica di titsch – spiega Nicola Vicquery, presidente del Centro culturale walser, durante la tavola rotonda che ha concluso il pomeriggio -. Il nostro compito è di sensibilizzare i giovani sull’importanza della nostra lingua, facendo e far loro capire la ricchezza che hanno tra le mani, e l’altra è di fare rete con le altre associazioni walser” che nel 2028, dopo trent’anni, si ritroveranno di nuovo a Gressoney e Issime per il tradizionale Walsertreffen, il raduno delle popolazioni walser dell’arco alpino. Sull’insegnamento del tedesco nelle scuole della vallata – suddiviso in 2 ore e mezza alla settimana alla scuola materna, un’ora alle elementari e tre alle medie – “stiamo portando avanti con la Regione dei progetti che dovrebbero garantire un po’ più di presenza della lingua nelle nostre scuole”, conclude Vicquery.