Le api sono indicatori essenziali dello stato di salute dell’ambiente. E proprio da questa consapevolezza nasce Api-Alpes, un progetto transfrontaliero innovativo tra la Valle d’Aosta e il Cantone Vallese, finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera 2021–2027, che punta a monitorare la biodiversità alpina e la salute degli ecosistemi attraverso le api.
Il progetto – che coinvolge apicoltori, agricoltori, enti pubblici e istituti di ricerca – è stato presentato nel corso di una conferenza stampa venerdì 4 aprile, con la partecipazione di rappresentanti italiani e svizzeri, tra cui il sindaco di Châtillon Camillo Dujany, i vertici della Fondazione Apialpes e dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, oltre agli assessori regionali Luciano Caveri e Marco Carrel.
Api-Alpes prevede l’installazione di 12 apiari sentinella (6 in Valle d’Aosta e 6 nel Vallese), dotati di arnie digitali in grado di raccogliere dati su salute delle api, qualità dell’ambiente, presenza di inquinanti e specie invasive. Il progetto ha preso ufficialmente avvio nel gennaio 2025, durerà 30 mesi e si concluderà entro giugno 2027.
Nel corso del progetto verranno sviluppate: una banca dati scientifica transfrontaliera; buone pratiche apistiche e ambientali condivise; attività di divulgazione, formazione e promozione dei mieli alpini, anche attraverso un concorso e una festa del miele prevista per settembre 2025.
L’importanza del progetto è stata sottolineata durante la conferenza stampa dai diversi partner coinvolti, che hanno evidenziato il valore scientifico, agricolo e territoriale di Api-Alpes.
Per il sindaco di Châtillon, Camillo Dujany, si tratta di “un’opportunità per i nostri apicoltori, per la qualità del miele e per capire meglio l’ambiente in cui viviamo”. Le api, ha ricordato, “sono fondamentali per l’impollinazione, e la loro crescente mortalità è un segnale preoccupante. Abbiamo trovato microplastiche nei ghiacciai: un segno tangibile di inquinamento che dobbiamo conoscere e affrontare. Grazie a questo progetto possiamo farlo.”
Un allarme condiviso anche da Michel Rausis, vicepresidente della Fondazione Apialpes: “La mortalità delle api è in crescita. Le cause? Varroa, calabrone asiatico, agricoltura intensiva, cambiamento climatico. Api-Alpes si propone di costruire una base di conoscenze transfrontaliere, diffondere buone pratiche e comunicare i risultati alla popolazione.”
A confermare l’utilità del monitoraggio scientifico è stato anche Jean-Baptiste Moulin, direttore del Centro di competenza in apicoltura: “I mieli prodotti oltre i 1100 metri sono tra i più puri, ma mancano ancora dati strutturati. I nostri apicoltori osservano ogni anno nuovi fenomeni: occorre una piattaforma comune per raccogliere queste osservazioni e trasformarle in analisi condivise.”
Dal punto di vista della ricerca, Riccardo Orusa, coordinatore del progetto per l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ha evidenziato come Api-Alpes rappresenti un tassello importante per la salute delle api a livello europeo: “Le malattie apistiche, come la peste americana, sono un problema continentale. Il nostro Istituto è già impegnato col Ministero della Salute e questo progetto ci permette di rafforzare studi già in corso, anche su residui chimici e nuove minacce.”
Per la Regione Valle d’Aosta, Api-Alpes è anche un progetto strategico di cooperazione. L’assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, ha definito le api “le vere sentinelle del territorio”, collegando l’iniziativa alla tradizione dei rapporti tra la Valle e il Vallese: “La cooperazione tra Valle d’Aosta e Vallese è un’opportunità da cogliere. I legami storici sono forti: basti pensare al colle del Gran San Bernardo.”
Infine, l’assessore all’Agricoltura Marco Carrel ha ricordato il ruolo chiave dell’apicoltura nella filiera agricola regionale: “Quando si parla di agricoltura, spesso si guardano i grandi numeri. Ma è l’insetto più piccolo, l’ape, a essere al centro dell’ecosistema. Senza api non avremmo la fontina d’alpeggio. In Valle abbiamo circa 600 apicoltori, che producono 130 tonnellate di miele all’anno, di altissima qualità. Il 70 percento viene venduto localmente. Dobbiamo tutelare la nostra biodiversità, e per farlo abbiamo bisogno di ricerca.”




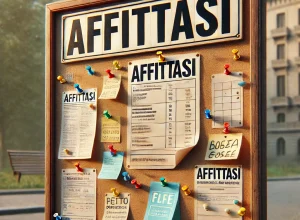





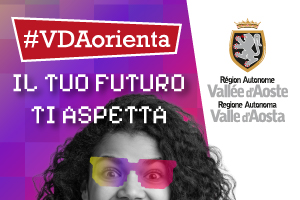

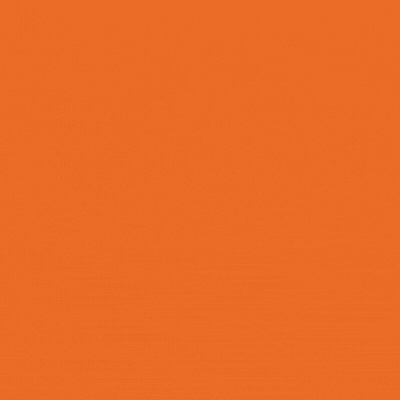

Una risposta
Come partecipare dalle Marche?