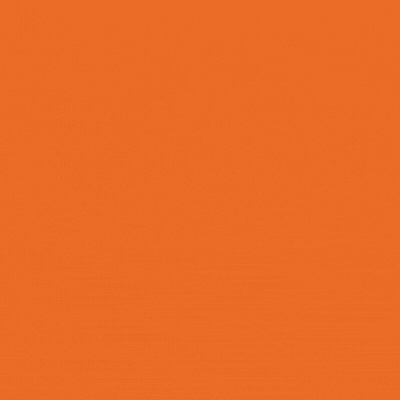Finalmente è arrivato uno dei momenti più attesi dall’industria cinematografica e dai cinefili di tutto il mondo: nella notte di oggi, tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, si terrà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024. In questa nuova puntata di “Incontri ravvicinati con AIACE”, vi presentiamo i dieci film candidati all’Oscar come “Miglior film” e le nostre top 5!
La zona d’interesse di Jonathan Glazer
UK/Polonia, 105 min, drammatico
Passato poco tempo dalla sua uscita, il capolavoro di Glazer ha già scritto la Storia del cinema e riscritto la Storia. O meglio, l’ha analizzata da un punto di vista completamente nuovo, prendendo in causa la piena consapevolezza dello spettatore, dato che nel film non può vedere nulla nel campo, sia cinematografico che di concentramento. Fresco del Gran Prix Speciale della Giuria a Cannes, ora lo vediamo candidato a ben 5 premi Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura non originale, film internazionale, colonna sonora. Inutile dire che meriterebbe di vincerli tutti, ma si tratta di un film che è difficile circoscrivere alla logica dell’Academy, che ha sempre dimostrato preferenza per ben altri tipi di opere.
La sua straordinarietà è innanzitutto su un piano puramente cinematografico. Utilizza le immagini per parlare di immagini, oltre al contenuto storico, che si intreccia indissolubilmente con la forma che è stata scelta per raccontare l’inimmaginabile. La famiglia ridente e felice di Rudolf Höss vive a un muro di distanza dal campo di concentramento di Auschwitz e per abitudine ignora ciò che accade oltre la barriera. Perché la disumanizzazione dell’Altro è alla base dell’indifferenza, il motivo per cui Höss riesce ad andare a dirigere Auschwitz come un qualsiasi everyday man. Va a lavorare in ufficio, per poi tornare a casa la sera e baciare affettuosamente sulla fronte moglie, figli, il cane; riesce anche a portare alla sua amata preziosi regali, una pelliccia di visone da vera diva del cinema, un rossetto perfetto per il colore roseo della sua pelle; ma anche dei curiosi giocattoli per i figli, come dei denti umani.
Si torna sempre al concetto di banalità del Male, forse mai filmato con così tanto rigore e rispetto per le vittime. Se l’orrore è talmente grande per essere comprensibile, lo è ancora di più quando si tratta di rappresentarlo. La conseguenza più logica è non mostrarlo direttamente, appellandosi al fuoricampo, zona che nella storia del cinema è stata esplorata in ogni meandro, da Jacques Tourneur a László Nemes. Proprio Nemes nel 2015 girò Il figlio di Saul, uno dei passaggi più importanti per quanto riguarda la Morale della rappresentabilità della Shoah, uno dei maggiori dilemmi artistici del Novecento, forse inaugurato dalla celebre recensione di Jacques Rivette a Kapò di Pontecorvo e assunto a poetica da Claude Lanzmann. Per chi non masticasse la storia dei Cahiers du Cinéma come pane quotidiano, Rivette denunciò l’oscenità di una scena in cui la camera indugia con una carrellata in avanti sulla morte della Riva che si getta sul filo spinato del campo di sterminio, facendo dell’orrore uno spettacolo dai fini estetici e immorali. Per certi versi, anche Benigni (La vita è bella) e Spielberg (Schindler’s list) si sono allineati con la pellicola di Pontecorvo, scegliendo la catarsi emotiva e il sentimentalismo per raccontare il capitolo più oscuro del XX secolo.
Invece Nemes riesce in un’impresa quasi impossibile: mostrare la tragedia dall’interno del campo. Tenendo ogni elemento cruento lontano, sfocato e invisibile se non attraverso l’udito e un sapiente uso del sonoro, possiamo considerare questo film la controparte complementare a quello di Glazer. Proprio il suono è uno dei punti di forza di La zona d’interesse, unico modo per sapere cosa accade oltre il giardino fiorito. Ma Glazer si ferma prima. Al di qua del muro, nella zona d’interesse. Senza se né ma, un capolavoro destinato a segnare la storia della settima arte.
Barbie di Greta Gerwig
USA, 2023, 114 min, commedia, musical
A posteriori possiamo dirlo: Barbie è stato un vero e proprio fenomeno culturale, ha battuto numerosi record e, adesso, come conseguenza naturale, si ritrova nuovamente a brillare sul tappeto rosso (ma sarebbe meglio rosa). La bambola iconica si scontra ancora con il padre della bomba atomica, vantando ben otto candidature ai premi Oscar, tra cui miglior film, sceneggiatura non originale, attore non protagonista (Ryan Gosling), attrice non protagonista (America Ferrera), scenografia, costumi e due canzoni (I’m just Ken e What was I made for?). Nel film di Greta Gerwig, Ken è felice solo quando Barbie lo guarda. Perché Barbie parla anche, e soprattutto, di sguardo: sociale, (a)sessuale, politico, spettatoriale. I concetti base del femminismo vengono esposti per la prima volta a una bambola, ignara dell’esistenza del virus del patriarcato. Se il monologo della madre interpretata da America Ferrera appare banale o didascalico, non è perché Greta Gerwig non sa trattare in modo serio il femminismo, ma al contrario sa come spiegare concetti culturali complessi in modo semplice al pubblico più ampio possibile, bambine incluse. D’altronde stiamo parlando di un blockbuster, non un film sperimentale.
Non stupisce poi che il 99% delle critiche negative siano provenute dal pubblico maschile, che sembra abbia avuto varie difficoltà nell’adottare un punto di vista opposto al proprio. E dal sincretismo tra commedia, giostra commerciale ed emancipazione femminile otteniamo un divertentissimo cocktail camp, un’opera profondamente superficiale, come amava definirsi il re della pop art Warhol, ma incredibilmente cinefila. Le più varie citazioni spaziano da 2001: odissea nello spazio (ormai cult il teaser e l’incipit) a Cantando sotto la pioggia, passando per PlayTime di Jacques Tati o i Monthy Python. Si crea poi un cortocircuito, specchio del contemporaneo, tra capitalismo (cioè il cinema stesso, arte-industria) e satira del capitalismo, verso la Mattel e i suoi direttori. Un Adamo ed Eva alla rovescia, dove Ken nasce dalla costola di Barbie e i due devono andare via dal paradiso Barbieland verso il mondo reale, percorrendo una strada di mattoncini rosa, ma non alla ricerca del mago di Oz: Barbie, che ricorda l’ingenuo Candide di Voltaire, cerca sé stessa, verso un’irreversibile scoperta delle difficoltà del nostro quotidiano. Non le resta che trasformarsi da icona per le bambine di tutto il mondo (e condanna per gli standard estetici) a donna in carne e ossa.
Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese
USA, 2023, 206 min, drammatico, storico, thriller, western
Con la partecipazione congiunta dei due suoi attori feticcio De Niro-Dicaprio, il maestro Martin Scorsese attraverso il suo ultimo lungometraggio, Killers of the Flower Moon, narra una storia americana cruda, adattata dal romanzo Gli assassini della terra rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI. Una storia di frontiera di David Grann. Siamo negli anni ’20 del secolo scorso in Oklahoma: un gruppo di Nativi americani della tribù Osage scopre la ricchezza che la loro terra nasconde sotto i propri piedi, il petrolio. La notizia corre in fretta ed improvvisamente molti tra loro vengono uccisi o scompaiono misteriosamente. Ad indagare sulla faccenda giunge l’astuto ranger Thomas White (Jesse Plemons), un agente della neonata FBI.
Intanto, Ernest Burkhart (Leonardo Dicaprio), uno sciocco ex soldato reduce della Grande Guerra giunto nella contea Osage, capirà che dietro ai crimini sui quali si indaga c’è proprio lo zio William Hale (Robert De Niro), ricco proprietario terriero che della corruzione e della violenza fa il suo marchio di fabbrica, tanto da soggiogare il nipote, convincendolo a sposare l’indiana Mollie (Lily Gladstone), per avere la possibilità di appropriarsi di quei ricchi terreni. Scorsese torna ad indagare gli aspetti più torbidi dell’animo umano, l’avidità, la crudeltà e il razzismo, ma stavolta sotto una luce diversa rispetto al passato: i personaggi criminali, quelli che incarnano il male, sono demistificati, non più affascinanti e attrattivi per lo spettatore, bensì viscidi, grotteschi, mediocri. A fare le spese delle loro azioni sono una comunità di Nativi americani, stavolta messi in risalto non come semplici selvaggi a cavallo o nemici da combattere, ma come individui che hanno dovuto sopportare tante angherie, privati delle loro terre e della loro storia.
Killers of the Flower Moon è un film cupo: nei toni con cui si presentano i colori della fotografia, nelle note della colonna sono stile country, nella storia raccontata e messa in scena da un cast strepitoso. Robert De Niro è un fuoriclasse nell’interpretare individui di moralità ambigua e senza scrupoli, Leonardo DiCaprio aggiunge una nuova sfaccettatura alla sua storia filmografica (per certi versi qui si riscontrano similitudini con la sua prova in Shutter Island), Lily Gladstone è una presenza calma ma carismatica in un mare in tempesta attorno a lei. La lunghezza della pellicola forse è un po’ eccessiva (3 ore e 26 minuti), però nel complesso abbiamo di fronte un’opera di primo piano che è riuscita ad ottenere ben 10 candidature ai prossimi Oscar e che forse potrebbe portarne a casa un paio tra reparto tecnico ed attrice non protagonista. Non ci resta che scoprirlo questa notte.
American fiction di Cord Jefferson
USA; 2023; 117 min; commedia, drammatico
La scena iniziale della commedia drammatica di Cord Jefferson, American Fiction, evidenzia da subito uno spirito satirico piuttosto caustico riguardo la banalizzazione della cultura afroamericana contemporanea. Il protagonista è l’autorevole professore universitario e scrittore Thelonious Ellison detto “Monk” (Jeffrey Wright). Esponente della narrativa afroamericana di alto livello, è terribilmente insofferente per il modo con cui i lettori bianchi elogiano gli autori black di oggi, capaci solo di prodotti “preconfezionati”, a base di storie crude e ad elevato contenuto drammatico. Tutto questo a discapito di libri come quelli di Monk, che sono invece più complessi, più fini, che richiedono una maggiore riflessione di fondo e che, quindi, vengono rigettati in quanto ritenuti noiosi.
Trasferitosi a Boston dopo essere stato allontanato dalla sua università, Monk ritrova una famiglia alquanto disfunzionale ad accoglierlo, che mette a dura prova il suo autocontrollo. Esasperato dalla situazione difficile venutasi a creare sia in ambito privato sia lavorativo, in un impeto di collera decide di scrivere, quasi per scherzo, un nuovo libro molto provocatorio che contiene tutti gli stereotipi che tanto disprezza. Incredibilmente, la ricezione entusiastica dell’opera lascia di stucco Monk, che si ritrova ora a gestire il dilemma tra andare avanti indomito nella sua crociata contro la semplificazione dell’arte e della cultura afroamericana contemporanea oppure cavalcare l’onda del mainstream mediatico per soddisfare il proprio ego e il bisogno di denaro.
American Fiction ha tutte le carte in regola per essere definito un ottimo film. La sceneggiatura, tratta dal romanzo Erasure scritto da Percival Everett, è ben articolata, lascia lo spazio e le pause per una riflessione seria sul tema di fondo della pellicola, ma anche sulle complesse dinamiche familiari che possono instaurarsi quando si è colpiti da eventi traumatici (lutto, separazione, malattia). Peccato solo per il finale che forse poteva essere più incisivo e graffiante in termini emotivi. Il lavoro sui personaggi compiuto dagli attori è stato superbo: da Jeffrey Wright, per aver dipinto perfettamente la frustrazione dell’uomo medio (Monk), a Sterling K. Brown, per le “sfumature di eccessi” del fratello di Monk (Cliff), e ad Erika Alexander, per la profondità e la delicatezza di Coraline, compagna del protagonista. Infine, pollice in su anche per la colonna sonora dalle tinte jazz composta da Laura Karpman. Cinque nomination agli Oscar per American Fiction, che di certo non sono frutto del caso ma di una scrittura egregia, ottime idee, una buona dose di ironia.
Oppenheimer di Christopher Nolan
Usa, Regno Unito, 2023, drammatico, biografico, storico
Una delle chiavi di lettura del film è nel titolo del libro vincitore del premio Pulitzer a cui si ispira Christopher Nolan: American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin. In un esplicito intreccio tra mitologia e realtà, Oppenheimer (Cillian Murphy) viene rappresentato come un prometeo moderno all’interno di una parabola esistenziale tesa tra trionfo e tragedia. Prometeo, etimologicamente “colui che vede prima”, è nella mitologia greca il Titano che ruba il fuoco agli dei per donarlo agli uomini e che viene punito da Zeus per la sua azione. Nel Novecento, R.J. Oppenheimer è il fisico a capo del progetto Manhattan che progetta la bomba atomica dando all’umanità un fuoco distruttivo potenzialmente sterminatore del mondo e che verrà inchiodato per la propria stessa creazione.
Il film di Nolan, attraverso una scomposizione della linearità degli avvenimenti, racconta la vita del fisico e il suo percorso professionale dalla teoria alla pratica: si va dallo studio ai progetti a Los Alamos, al test nucleare di Trinity, dallo scoppio della bomba su Hiroshima e Nagasaki all’udienza a porte chiuse che lo accusava, in pieno maccartismo, di essere un pericolo per la sicurezza nazionale. Il tempo, topos del cinema di Nolan che lo manipola (Memento), cristallizza (Insomnia), manda indietro (Tenet), sviscera nell’onirico (Inception) e nello spazio (Interstellar), è in Oppenheimer un conto alla rovescia. In attesa della creazione. E dell’arrivo dell’esplosione.
Per immergersi meglio nella mente e nella vita del suo protagonista, Nolan scrive la sceneggiatura in prima persona e sceglie un’estetica che rispecchia l’oscillazione tra soggettivo e oggettivo: in bianco e nero, c’è l’oggettività della storia; a colori, c’è la storia attraverso la soggettività del protagonista. Ma l’accesso all’interiorità dell’uomo rimane parziale: Nolan perlustra la mente umana dedicando a Oppenheimer tantissimi primi e primissimi piani che lo mettono in risalto dallo sfondo, dal mondo e dagli altri, ma l’uomo rimane un mistero, tra luci e ombre, fama e caduta, ricerca scientifica del pericolo – della fine e della morte – e crisi morale nei confronti della propria stessa creazione. Come Prometeo, Oppenheimer lo aveva già visto prima. Un evento che cambia la storia dell’umanità. Un’esplosione che porta con sé un nuovo inizio. Un tempo da cui non si può più tornare indietro. Grande favorito alla corsa delle statuette, il film di Nolan ha 13 nomination agli Oscar 2024, tra cui miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista.
Poor Things! di Yorgos Lanthimos
USA, 141 minuti, Commedia/Sci-Fi
Il Leone d’Oro all’80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e candidato a 11 premi Oscar “Poor Things!” si è decisamente guadagnato un posto di rilievo tra i grandi film del 2023. Il regista greco Yorgos Lanthimos inizia a sviluppare l’idea di questo ambizioso progetto nel 2009 quando incontra in Scozia l’autore dell’omonimo romanzo che ha ispirato la pellicola, Alasdair Gray. Nello stesso anno produce un altro film magistrale della sua filmografia, “Dogtooth”, in cui è possibile notare la somiglianza tematica della scoperta sessuale che è centrale in entrambi i film ed è il motore di crescita dei personaggi. In “Poor Things!”, Bella Baxter (Emma Stone) è una creatura frutto delle miracolose mani del chirurgo e scienziato Goldwin Baxter (Willem Dafoe), che trapianta nel corpo di una donna morta suicida nel Tamigi il cervello del feto che la stessa portava in grembo, generando così un essere in pieno sviluppo in un corpo già costituito.
Cresciuta e studiata all’interno di un Eden di stranezze, Bella passa per tutte le fasi infantili di scoperta del proprio corpo e risponde ai propri impulsi partendo per avventure mirabolanti in diverse città del mondo al fianco, finché non si stufa, del sordido avvocato Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo). Gli scambi tra i due personaggi rivelano sempre di più la profondità del pensiero di Bella e trasformano l’avvocato da seduttore che abbandona in un povero innamorato abbandonato. Se all’inizio vediamo una Bella concentrata solo sulla sfera sessuale, in un secondo momento la vediamo prendere coscienza della miseria umana. Dopo una crisi, Bella reagirà con azioni che la porteranno a continuare il suo viaggio da sola e a concretizzare sempre di più la sua indipendenza ed il suo impegno sociale.
La dimensione decorativa di “Poor Things!” è studiata nei minimi dettagli: sin dal romanzo di Gray fuoriescono vivide illustrazioni che definiscono i tratti del mondo in cui la storia si sviluppa e che il regista approfondisce con l’aiuto di due scenografi di eccezione (James Price e Shona Heath). I richiami organici degli interni e dei costumi dei personaggi sono un continuo rimando alla chirurgia, matrice importante di questo film, che lascia pensare ad una recente pellicola di Cronenberg, “Crimes of the Future” (2022), in cui il motto è “la chirurgia è il nuovo sesso”. L’atmosfera surreale e disturbante che l’elemento chirurgico attribuisce a “Poor Things!”, al di là del fattore estetico, può essere anche vista come una metafora della ricerca dell’autenticità e della vera identità. Bella, con il suo corpo modificato chirurgicamente, è costretta a confrontarsi con la sua natura, sfidando le convenzioni sociali e le aspettative degli altri. Il film è stato generalmente molto ben accolto dalla critica, che è rimasta stupita in particolare dalla magistrale recitazione dei personaggi, dall’originalità della regia e della sceneggiatura.
Un film fantascientifico che con la sua estetica steampunk ed il suo ottimismo surrealista porta sul tavolo temi su cui riflettere quali la figura della donna, la ricerca del sé e la ribellione tutto questo mentre il piacere estetico è più che appagato. Il confronto con Barbie, è suggerito: entrambi i film si fanno portatori di un discorso sulla femminilità e sul ruolo delle donne nella società che punta a sfidare lo stereotipo e mettere in crisi il sistema. Interessante osservare che in entrambi i film la danza abbia un ruolo liberatorio e di presa di posizione. “Poor Things!” risulta un’opera rocambolesca e affascinante che auspica di brillare nella Notte degli Oscar, detto altrimenti con una frase della magnifica Bella Baxter, “What Bella wants, Bella gets”.
Anatomia di una caduta di Justine Triet
Francia, 153 minuti, Giallo/Thriller
Palma d’Oro al festival di Cannes, Anatomia di una caduta è un film analitico che indaga la forza delle parole, soprattutto di quelle che non si dicono, candidato agli Oscar come Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista, Miglior suono e Miglior sceneggiatura. Sandra Voyer (Sandra Hüller) suo marito Samuel Maleski (Samuel Theis) e il figlio Daniel (Milo Machado-Graner) vivono in uno chalet in montagna nel paese dove Samuel è cresciuto. Daniel, uscito per una passeggiata con il cane Snoop, lascia a casa i genitori e al suo ritorno trova appena fuori dall’abitazione il corpo morto del padre. Come è avvenuta la sua morte e cosa l’ha causata? In questo film l’astuzia della regista Justine Triet sta in ciò che decide di non mostrarci, nelle zone d’ombra attorno alle quali la narrazione si sviluppa, nei dettagli della vita dei personaggi e del loro passato che influenzano drasticamente i fatti del presente che ci racconta.L’ambito sonoro è quello in cui le zone d’ombra si manifestano principalmente: quando fuso profondamente con l’immagine è fatto di parole spesso accusatorie o ingannevoli, comunque sempre permeate di dubbio e incertezza, quando è scisso da essa manifesta la dimensione fantasmatica in cui l’immaginario può interpretare e scegliere da che punto di vista percepire i suoni che raccoglie.
La narrazione si sviluppa lentamente, esattamente come la depressione del marito di Sandra Voyer. Ogni seduta in tribunale rivela qualche nuovo aspetto sui personaggi che ci vengono mostrati, le inquadrature strette sulle espressioni del loro viso sui loro gesti ci approcciano ad una ricerca della verità ma un velo di opacità è sempre presente e ci allontana continuamente dalla certezza. Cerchiamo di comprenderne l’anatomia di ciò che è accaduto ma il fatto in sé, nella sua inspiegabilità rivelabile, rimane soggettivo. Si tratta di credere o non credere. Come in Rashomon di Akira Kurosawa (1950), la rilevanza della verità raccontata da ogni singolo testimone sull’assassinio è fallace e non rappresenta la verità. L’ignoto permea non solo la realtà fisica dello svolgimento dei fatti ma la comprensione mentale della condizione per la quale questi si manifestano. E alla fine è sempre un soggetto innocente a fornire la risoluzione del problema, a riportare la pace e il silenzio nelle mille parole degli adulti che si ingannano tra di loro prima per poi rendersi conto di tradire ancor prima se stessi.
Cosa si può fare quando un fatto risulta inspiegabile, si è guardato ovunque per capire come è accaduto e ancora non c’è risposta? Ci si chiede il perché e si fanno emergere i motivi: bisogna decidere. Anatomia di una caduta fornisce continuamente elementi per pendere da una parte all’altra, per perpetuare un’oscillazione che rende difficile il posizionamento. Fa immaginare che possa comparire qualche elemento nuovo che convinca una delle due parti ed umili l’altra, ma di fatto nessuno esce vincitore da questa storia.
Past Lives di Celine Song
USA, 2023, 106 min, drammatico, sentimentale
“C’è una parola in coreano… In-Yun. Significa provvidenza o destino. Ma riguarda specificamente le relazioni tra le persone. Penso che derivi dal Buddismo e dalla reincarnazione. È un In-Yun anche se due sconosciuti si incrociano per strada e i loro vestiti si sfiorano accidentalmente. Significa che ci deve essere qualcosa tra loro nelle loro vite passate.” Questo concetto riassume tutta la profondità e le sfumature della connessione tra esseri umani e della loro identità. È l’elemento portante di Past Lives, pellicola diretta e scritta meravigliosamente da Celine Song, regista sudcoreana che, prendendo spunto da alcuni elementi autobiografici, crea un’atmosfera così intima, così profonda, così nostalgica che non può lasciarci indifferenti.
La storia racconta del profondo legame tra Nora e Hae Sung, due amici di infanzia coreani che, dopo una serie di eventi che li hanno separati per circa 20 anni, si rincontrano a New York per trascorrere del tempo insieme e riflettere principalmente sulle scelte e sul destino che li ha tenuti distanti l’uno l’altro. Tutti nella vita sicuramente abbiamo avuto dei rimpianti per quelle occasioni sfumate nelle relazioni amorose, quelle situazioni idealizzate che ci hanno fatto immaginare “come sarebbe potuta andare se…“. Dunque, la realtà dei protagonisti, interpretati dai bravissimi Greta Lee e Teo Yoo, è stata o è anche la nostra: in bilico, sul filo tra un “lasciar andare per una nuova vita” e un “tornare indietro per riprendere le fila di una vecchia“. Per certi versi il film richiama le stesse good vibes suscitate dal capolavoro di Richard Linklater Prima dell’alba, ma anche dalla serie TV Normal People. Queste storie fanno breccia nel cuore di ognuno di noi, ponendoci in dialogo con il nostro vissuto e con tutti quegli amori che non abbiamo dimenticato, quegli amori veri e forti che non possono che coincidere con gli unici mai consumati e soltanto desiderati.
Maestro di Bradley Cooper
USA, 2023, 129 min, drammatico, sentimentale
Il giovane compositore Leonard Bernstein alla sola età di 25 anni ottiene l’occasione della vita: viene chiamato per sostituire all’ultimo minuto Bruno Walter, di cui è assistente da qualche mese, alla direzione della Filarmonica di New York. Proprio su questo evento, si apre il film di Bradley Cooper, che oltre ad essere regista del film ne è anche produttore, sceneggiatore e attore principale, interpretando lui stesso Bernstein. Una scelta particolare che non mostra quindi mai il periodo di gavetta del musicista, anche perché in realtà non c’è mai stato: la grande occasione di Leonard arriva a soli due anni dalla fine dei suoi studi e quella sera dirige l’orchestra magistralmente. Da allora, la sua carriera sarà costellata di grandi successi sia come direttore d’orchestra che come compositore di balletti, opere, concerti da camera e musical, tra cui le canzoni di West Side Story e la colonna sonora di Fronte del Porto che lo porteranno ad essere definito il primo grande compositore americano, l’unico direttore d’orchestra statunitense ad ottenere riconoscimenti anche al di fuori degli Stati Uniti. Il suo talento era tale che né la sua bisessualità né le sue origini ebraiche hanno rallentato la sua carriera.
Il film di Cooper, anziché concentrarsi sull’uomo musicista, si concentra allora sull’uomo padre di famiglia e marito fedifrago. Nel 1951 sposa infatti la giovane attrice Felicia Cohn (interpretata da una sempre formidabile Carey Mulligan) da cui ebbe tre figli. Felicia rinunciò alla sua carriera di attrice per dedicarsi completamente alla famiglia e tollerò per tutta la sua vita le scappatelle del marito che finì per lasciarla per uno dei suoi giovani studenti. Il rapporto tra Felicia e Leonard è il fulcro del film, un rapporto mancante certamente di equilibrio e intrinsecamente deprimente dove lui ha avuto tutto quello che desiderava e lei ha rinunciato a tutto quello che sognava di essere per amore del marito.
Il film si regge sulle ottime interpretazioni del cast (tralasciando la povera Sarah Silverman che amiamo molto generalmente e che si ritrova qui a interpretare la macchietta dell’ebrea borghese di città) e sull’ottima fotografia di Matthew Libatique, collaboratore storico di Aronofsky, mentre la narrazione è piatta tanto quanto la vita facile del protagonista. Sorprende quindi non poco vedere il film candidato non solo nella categoria miglior film, ma anche nella categoria miglior sceneggiatura originale. In totale, ha ottenuto 7 nomination (Miglior attore per Bradley Cooper, miglior attrice per Carey Mulligan, miglior fotografia per Matthew Libatique, miglior sonoro per Richard King, miglior trucco per Kazu Hiro). Considerando gli altri candidati nelle stesse categorie, ci auguriamo torni a casa senza statuette.
Questo film riapre certamente uno dei grandi dibattiti della storia del cinema: quali sono le storie che meritano di essere raccontate? Domanda a cui è (quasi) impossibile dare una risposta. Mi ha anche fatto tornare in mente uno degli insegnamenti che meglio ricordo dall’epoca dell’università, il professore di sceneggiatura infatti un giorno disse in classe “attenzione a parlare della vostra vita quando scrivete un film, ci sono forti possibilità che non sia per niente interessante”. Ci aspettiamo che vinca l’Oscar al miglior film? No. Vorremmo lo vincesse? Assolutamente no.
The Holdovers di Alexander Payne
USA, 133 minuti, commedia, drammatico
Ambientato all’inizio degli anni ’70, “The Holdovers” narra le vicende di Paul Hunham (Paul Giamatti), un professore dal carattere difficile, costretto a trascorrere le vacanze di Natale con un gruppo ristretto di studenti, tra i quali spicca il giovane Angus Tully (Dominic Sessa), e la cuoca Mary (Da’Vine Joy Randolph). La trama si snoda attorno alle dinamiche che si sviluppano tra questi personaggi, le cui personalità, inizialmente divergenti, danno vita a un legame inaspettato. In quest’opera la poetica di Alexander Payne emerge con forza, combinando umorismo e dramma in una narrazione che esplora la complessità delle relazioni umane.
Il film riflette temi ricorrenti nella filmografia di Payne (Sideways – In viaggio con Jack, Paradiso amaro, Nebraska) come il senso della famiglia e la trasformazione personale attraverso il contatto umano. Paul Giamatti, nel ruolo del protagonista, offre una delle performance più brillanti della sua carriera, tanto da renderlo uno dei favoriti per la statuetta al miglior attore. Il suo personaggio è un anti-eroe pieno di difetti, ma profondamente umano, una figura ricorrente nelle opere di Payne, che spesso esplorano l’umanità dei personaggi in contesti di grande trasformazione emotiva e personale. La commistione tra dramma e commedia funge da veicolo per un viaggio emozionale che, pur essendo profondamente radicato in un’epoca, riesce a parlare a un pubblico ampio e variegato, evidenziando la maestria di Payne nel raccontare storie che, nonostante la loro specificità, risuonano universalmente. Un “instant classic” per quanto riguarda i film a tema natalizio.