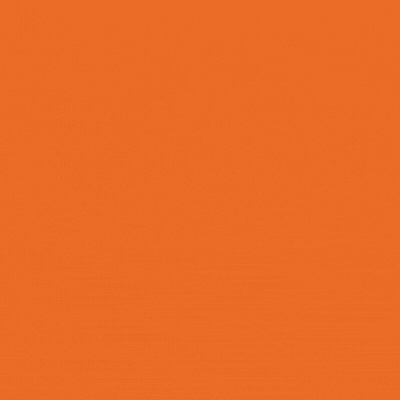In questa puntata di “Incontri ravvicinati con AIACE”, Ludovico Franco vi consiglia 7 grandi titoli per 7 grandi registi, tutti disponibili gratuitamente su YouTube.
Facciamo un esperimento: entriamo in una macchina del tempo. Torniamo alla costruzione della sfinge? O alla distruzione di Pompei? Meglio di no, non c’è bisogno di andare così indietro. E 100 anni fa? Il 1924, perfetto. Di cosa potremmo essere testimoni diretti? A parte fatti storici come l’uccisione fascista di Matteotti, assisteremmo alla pubblicazione della Montagna incantata di Thomas Mann, o di La signorina Else di Schnitzler. Potremmo avere addirittura il privilegio di essere spettatori di Ciascuno a suo modo di Pirandello. Ormai da trent’anni il cinematografo divampa e sconvolge, solo con il potere delle immagini. Il cinema muto e senza voce può essere accompagnato, come in una performance live, da un imbonitore o un piano che, timido e al buio, tenta di commentare la luce sullo schermo, filtrata ogni tanto da nuvole di fumo di qualche spettatore. Forse entrare in una sala cinematografica può essere una delle esperienze più totalizzanti che faremmo se tornassimo indietro al 1924. D’improvviso, scopriremmo meraviglie. Non nello stesso istante e luogo sulla terra, ovviamente.
Se oltre a viaggiare nel tempo potessimo sorvolare mari e monti, vedremmo il meglio che ogni paese ha prodotto per la settima arte. Infatti un secolo fa uscivano innumerevoli, immensi, immortali capolavori. Tutti diretti dai maggiori maestri mondiali. I 7 film qui riportati sono tutti rappresentativi del muto e dei registi che hanno dato il meglio di sé in quest’epoca d’oro del cinema – anche se Lang, Lubitsch, Dreyer e Walsh raggiungeranno una nuova e diversa maturità con il sonoro. Avremmo potuto ugualmente inserire molti altri titoli, come The hands of Orlac di Robert Wiene, He who gets slapped di Victor Sjöstrom, L’inhumaine di Marcel L’Herbier e Il cavallo d’acciaio di John Ford. Chissà quanti altri capolavori oggi perduti potremmo vedere, se solo esistesse una macchina del tempo (il primo titolo che affronteremo è paradigmatico in questo senso).
Purtroppo i dati parlano chiaro: si calcola che circa l’80% del cinema pre sonoro è da considerare irrecuperabile, almeno per ora. Tuttavia dobbiamo ricordarci che anche dei film muti sopravvissuti alla prova del tempo spesso non possiamo conoscere un’unica versione corretta o definitiva: tra le varie copie reperibili cambiano durata, montaggio, didascalie, spesso anche il colore. Il cinema muto è affascinante forse anche per questa sua natura archeologica per come la intendeva Foucault, una storia dalla conoscenza imperfetta, sfuggente, manchevole. Come un fantasma.
RAPACITÀ di Eric von Stroheim
Un’opera folle, smisurata, ambiziosa, maledetta, fagocitante. Quasi suicida. Perché il genio visionario di Eric von Stroheim compromise per sempre la sua futura carriera a Dreamland, nel tentativo di produrre questa epopea familiare nel cuore dell’America. Un paese nato macchiando il denaro col sangue, immagine ricorrente e insistita che emerge a tratti dalla vicenda narrata.
Così il titolo spiega la trama: il decadimento cannibalico di una coppia colpita dal virus patologico del denaro. Un’autentica ossessione che spinge lo sguardo ai limiti della tollerabilità, così come insostenibile e folle era la produzione stessa. Stroheim si accanisce sulla realtà così a lungo che prima o poi essa finisce per mostrare, da sola, il suo ribaltamento osceno, la sua corruzione, l’infima meschinità della condizione umana. E a ogni rinnovata visione si imprimono immagini indelebili di forza unica: le mani scheletriche avvinghiate sulle monete d’oro, il gatto che attacca il canarino nella gabbia, la volgarità di una banana mangiata a un pranzo di nozze, l’ironico funerale visto dalla finestra mentre si svolge il matrimonio, il deserto sovrumano della Valle della Morte.

La profondità di campo riesce a collocare sui diversi piani dell’immagine le pulsioni più sfrenate di un universo in pieno disfacimento, marcescente come una carcassa nel deserto. Stroheim realizza sempre le sue opere con uno spirito decadente ma allo stesso tempo naturalista e il risultato non può che essere la deformazione grottesca e sadica dell’ipocrisia dell’uomo. In origine dovevano essere 462 minuti, ma la MGM massacrò il progetto faraonico per ridurlo a 140 minuti (100 in alcune distribuzioni). Ciò che resta oggi è una traccia mutilata delle intenzioni originali, ma resta pur sempre una delle vette del muto, il massimo exemplum (vent’anni prima di Welles) di come spesso la libertà creativa degli artisti che tentavano troppo di imporsi come auteur individuali a Hollywood veniva castrata dai produttori.
LA PALLA Nº 13 di Buster Keaton

LA PALLA Nº 13 di Buster Keaton
Basta una singola scena a trasformare un film nel Cinema, il suo statuto ontologico, estetico, immaginifico. In una geniale quanto semplice mise en abyme, Buster Keaton inquadra lo schermo cinematografico, senza tralasciare una parte del pubblico e, dettaglio non irrilevante, il pianista che musica dal vivo lo spettacolo muto (regalandoci così un magnifico spaccato dell’epoca). Con un controcampo giustifica l’inquadratura precedente e svela la sua natura di soggettiva: il punto di vista sulla sala è di Buster, ma contemporaneamente è quello di tutti noi, la totalità degli sguardi degli spettatori di fronte al grande schermo.
Altro dettaglio fondamentale è il fatto che questa ripresa è ancora una mise en abyme: vediamo la maschera-volto pallida e glaciale di Keaton attraverso un’altra cornice. Dunque un simulacro dello schermo, una reificazione del cinema nel reale. O, per meglio dire, la trasformazione della realtà nel cinema, che esalta la banalità stessa di quella realtà inquadrata. Così il goffo proiezionista si addormenta e esce da quella cornice magica per accedere – fisicamente, con tutti e due i piedi – a un altro mondo, quello del film che sta proiettando, in un percorso uguale e contrario a quello dei personaggi della Rosa purpurea del Cairo.
Finita la magia del sogno diventato realtà, la realtà diventa il sogno: parallelamente vediamo scorrere le ultime immagini del film sullo schermo (il film nel film) alternate all’altro film improvvisato, quello del proiezionista goffo che incontra la sua ragazza. Ciò avviene sempre dentro alla cornice della finestra che li trasforma subito in dei divi, grazie alla natura fotogenica del gesto cinematografico, che inquadra la realtà, illumina il suo senso e lo eleva. Ma il giovane è così tanto goffo che non sa come deve baciare la ragazza. Così, quando lei non lo vede, si gira e volge lo sguardo verso il film, in cui i personaggi si stanno scambiando affettuose carezze. Guarda, impara, ripete. Il cinema, il mito, i modelli e la loro demistificazione allo stato puro. Pochi istanti trasformano un film nel Cinema tout court.
L’ULTIMA RISATA di F. W. Murnau

L’ULTIMA RISATA di F. W. Murnau
Un anziano portiere di un hotel berlinese, da molti anni una figura autorevole e socialmente rispettata, viene degradato a sorvegliante dei gabinetti. L’apoteosi dell’arte cinematografica. Solo immagini. Nessuna didascalia, Murnau non ha bisogno del verbo. Kracauer lo definì un film di puro istinto, perché l’istinto si trasmette reciprocamente tra schermo e spettatore e non necessita né di spiegazioni, né di dialoghi: istinti e passioni fioriscono al di sotto della dimensione del ragionamento discorsivo, e si prestano a essere descritti senza spiegazioni verbali, disturbo superfluo alla continuità visiva.
La trama è così intenzionalmente semplificata, ma raggiunge la dimensione di universalità esistenziale. Il capolavoro di Murnau segna una svolta nel kammerspielfilm di impianto psicologizzante, anche per un bisogno di realismo sociale da parte del pubblico. La realtà delle cose è sempre mescolata alla fantasia, come accadrà in Aurora. C’è poi l’importanza simbolica degli oggetti: la casacca indossata dal protagonista illustra l’importanza dell’uniforme nella Germania pre-nazista, e la sua perdita viene vissuta come una degradazione. Murnau dipinge maschere grottesche, che sembrano uscite dai quadri di Grosz, ma lo fa con affetto.
Per non parlare del doppio finale: l’annichilimento pessimista della vecchiaia è seguito da un finale posticcio imposto dalla UFA, in cui lo sfortunato usciere eredita una grande somma di denaro. Con il secondo finale si ribadisce il significato del primo e si respinge l’idea che la decadenza dell’Occidente si possa rimediare con i doni dell’Occidente. Il finale positivo è beffardo, di una durezza brechtiana, come un sogno nato per celare la mediocrità del reale. Ma il reale irrompe emergendo dalla sua simulazione e vince sul simbolico e l’immaginario.
I NIBELUNGHI di Fritz Lang

Non è il Lang più famoso, ma certamente è, dopo Metropolis, il suo più importante nel periodo muto. L’opera è una saga dei Nibelunghi divisa in due volumi, La morte di Sigfrido e La vendetta di Crimilde. Per ricreare questa epica fantastica, il regista tedesco attinge alla leggenda, all’immaginario comune in cui affondano le radici del suo paese. Soprattutto al noto ciclo di opere sinfoniche di Wagner sulla mitologia germanica, Der ring des Nibelungen. Ma più che la trama, Lang ne riprende il respiro, la tensione verso la ricerca della Gesamtkunstwerk (l’arte totale); più che decantare le glorie del leggendario popolo tedesco, Lang dà libero sfogo alla plasticità della sua arte per una maestosa composizione decorativa.
Crea immagini eidetiche, cioè vettori assoluti per la creazione di un senso. Lo stile e l’immaginario così si con-fondono per dare vita a una forma simbolica di alto valore estetico, in grado di esercitare un fascino unico sul pubblico. L’organizzazione delle inquadrature è effettuata con un rigore simmetrico, specie nella struttura dei décors e nella disposizione degli attori, in particolare le comparse delle scene di massa, statue ieratiche che si integrano alle architetture. Ed è proprio questa la differenza più evidente con Wagner: la cura formale di Lang è austera, stilizzata e glaciale, vera e propria architettura per immagini. L’equilibrio e la simmetria di sontuosi palazzi dominano la prima parte, mentre la seconda è contraddistinta dal caos della battaglia e le forme smussate e irregolari delle caverne barbare. Ma tutta l’opera è percorsa nel suo complesso da una tragica ineluttabilità.
Nella seconda parte Crimilde è una scultura di marmo, resa fredda e impassibile dalla morte di Sigfrido: il suo sguardo in macchina ricorrente è quasi la “manifestazione simbolica del pathos freddo e implacabile del film, sacralizzazione gelida e rituale del vedere, che è forse l’essenza stessa del cinema di Lang” (Paolo Bertetto).
IL LADRO DI BAGHDAD di Raoul Walsh

Il compianto Kenneth Anger scrisse il fondamentale (e divertentissimo) libro Hollywood Babylon in cui affresca con ironia e sguardo quasi da entomologo la fabbrica dei sogni, le sue contraddizioni, i suoi aspetti più sordidi. Soprattutto l’opulenza e la follia di alcune produzioni, come le immense scenografie babilonesi in cemento di Intolerance di Griffith, che ispirarono il titolo del volume. Ma, parlando in termini di opulenza e sfarzo, avrebbe tranquillamente potuto chiamarsi Hollywood Baghdad.
Il film di Walsh Il ladro di Baghdad è infatti sintomatico dell’intera industria hollywoodiana. Ci sono tutte le carte in regola: una storia ispirata alle Mille e una notte, grandi divi (Douglas Fairbanks), ricostruzione fiabesca dal gusto esotico e orientale, durata considerevole (per l’epoca due ore e mezza non erano poche), ambizione e ricchezza decorativa e formale. A perfezionare questa ricetta infallibile si aggiungono scenografie, costumi, trucchi ed effetti speciali e, ovviamente, una classica love story.
Impresa titanica pienamente riuscita grazie al genio del sistema (come amava definirlo Bazin). Insomma, oggi nascerebbe come un blockbuster fantasy, ma dopo pochi mesi perderebbe la sua forza. Alla storia delle immagini non resterebbe nulla se non luoghi fittizi ricreati in digitale davanti a un green screen. Del Ladro di Baghdad invece è impossibile dimenticare i palazzi e gli archi imponenti, che svettano verso il cielo come cattedrali gotiche con i loro portoni gargantueschi; o persino i trucchi più ingenui e artigianali come la magica corda che resta sospesa in aria e il celebre tappeto volante. Walsh privilegia così i campi lunghi e i totali, per abbracciare lo splendore dei décors nella sua interezza.
Solo nei momenti intimi ed emotivi sceglie di avvicinarsi agli attori con piani ravvicinati. Potremmo definirla l’altra faccia di Rapacità: per il film di Walsh la produzione collabora dando il meglio di sé e offre allo spettatore sogni antinaturalistici e fantastici. Walsh sarà poi riscoperto come autore, ma qui è la natura collettiva della settima arte a regnare sovrana.
DESIDERIO DEL CUORE di C. T. Dreyer

DESIDERIO DEL CUORE di C. T. Dreyer
Storia delle conseguenze dell’amore del famoso artista Claude Zoret nei confronti del giovane Michael, suo modello e fonte d’ispirazione che lo abbandonerà per una donna più grande. Nessuno è in grado di dipingere la sofferenza ontologica del genere umano come Dreyer, il più grande pensatore del cinema (come lo ha definito Sergio Grmek Germani).
Forse è stato l’autore più vicino al pensiero filosofico di Kierkegaard – suo connazionale – che metteva al centro delle sue riflessioni l’individuo, la sua soggettività, la sua esistenza, il tema della scelta. E, soprattutto, il timore e il tremore. Tutte tematiche che troveranno uno sviluppo magistrale nella fase tarda del suo percorso artistico, ma che già in questo Michael possiamo trovare in nuce. È un’opera che con-fonde pienamente estetica tardo ottocentesca e contemporaneità, gli ultimi residui dell’estetismo e del decadentismo incontrano il medium del Novecento. Infatti Claude Zoret potrebbe perfettamente uscire dalla penna di Wilde o D’Annunzio, è un dandy che colma il vuoto esistenziale con l’arte e l’amore per il giovane Michael, tra affetto paterno e attrazione sessuale. È già un (anti)eroe viscontiano ante litteram, e non solo per il fascino subito da un giovane ragazzo, all’epoca moralmente controverso.
Nel gioco del destino, l’arte imita la vita e la vita imita l’arte, come dimostra il grande ultimo capolavoro di Zoret: il dipinto raffigura un uomo solo, vecchio, nudo e rattrappito sulla spiaggia, di fronte all’immensa indifferenza della natura, come le raffigurazioni romantiche e sublimi di cui Friedrich è il nome più noto. Il paesaggio desolato riflette l’uomo: Zoret, così abituato a rappresentare aitanti corpi virili giovani, ora non può che mostrarne la piena decadenza, innanzitutto morale.
MATRIMONIO IN QUATTRO di Ernst Lubitsch

MATRIMONIO IN QUATTRO di Ernst Lubitsch
Vienna: tra due coppie di aristocratici si instaurano delle dinamiche simili a un teorema matematico che potremmo schematizzare così: la coppia Franz-Charlotte è felice, quella di Josef-Mizzi non lo è e aspira al divorzio. Mizzi vuole sedurre il marito dell’amica Charlotte, a sua volta corteggiata da Gustav.
Lubitsch è uno di quei maestri le cui acque non sono state turbate più di tanto dall’avvento del sonoro. Anzi, le sue commedie migliorano con la possibilità di udire i dialoghi, gli scambi di battute brillanti, la raffinatezza della scrittura. Non a caso le screwball comedies iniziano a esplodere a partire dagli anni Trenta, mentre le romantic comedies evolvono verso un’ironia più pungente. Ma la genialità del Lubitsch’s touch nel periodo muto non va confusa con una semplice tensione verso il sonoro, bisognosa di uno sviluppo tecnologico per esprimersi al meglio. No, qui c’è già tutta la sua autorialità, la regia attenta ai minimi dettagli, la wittiness del dirigere gli attori e dipingere l’ambiente sociale.
Prima di Partita a quattro, mette in scena la geometria della seduzione, gli scambi di coppia, gli equivoci, i rapporti sessuali mancati. Gioca con i suoi personaggi come combinazioni numeriche per congegnare al meglio il suo meccanismo scenico. In un certo senso si può adattare anche allo studio di Stanley Cavell sulle commedie americane classiche: analizzò un corpus di testi e rilevò una struttura narrativa comune, il cosiddetto ri-matrimonio, un uomo e una donna che passano da un felice matrimonio a un conflitto/divorzio, per finire di nuovo tra le braccia l’uno dell’altro. The marriage circle (titolo originale di Matrimonio a quattro) moltiplica la cifra della singola coppia ed esemplifica, sin dal titolo, il ritorno circolare alla condizione di equilibrio iniziale. Ma non con un mero lieto fine, sia chiaro. Perché il Lubitsch’s touch sa come lasciare lo spettatore nel modo più arguto possibile. Ma questo lo scoprirete da soli.
di Ludovico Franco