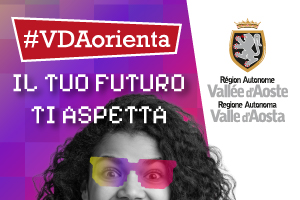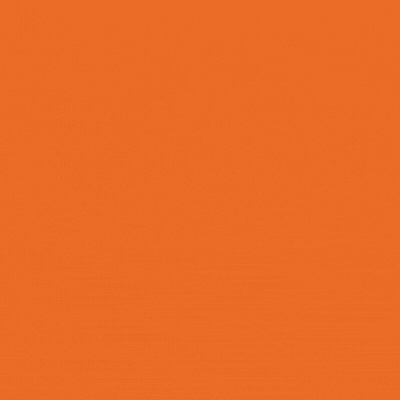AFTER THE HUNT di Luca Guadagnino (fuori concorso)
Maggie (Ayo Edebiri), studentessa di Yale, accusa un professore (Andrew Garfield) di molestie. L’ombra del dubbio circa la veridicità del caso incrina le vite perfette di altri docenti come un effetto domino. Tra questi non è esclusa Alma (una indelebile e ambigua Julia Roberts che recita con tutto il corpo e un dolore viscerale), stimata docente di filosofia che si ritrova in una scomoda posizione: a chi bisogna credere? Come non far affiorare il proprio passato? E, soprattutto, come non cadere nel baratro?
Luca Guadagnino dirige un thriller preciso come il ticchettio di un orologio e, seguendo la lezione hitchcockiana sulla suspense, manipola ciò che lo spettatore sa, vede e crede. Non gli interessano le risposte alle domande, ma come si muovono i personaggi nell’impasse di un aut aut che diventa il vero motore del meccanismo narrativo. Non conta stabilire la verità dei fatti – la molestia è accaduta? – perché tutto si scioglie in un’unica, grande bugia. Ciò che resta dopo la caccia è una sfida metanarrativa tra storytellers, ovvero ha la meglio chi, alterando lo sguardo altrui, è più abile a raccontare la propria versione dei fatti.
La discendenza è quella dei figli postmoderni dell’autore del Sospetto: De Palma, Fincher, Almodóvar, certi film di Allen e Polanski. La si riconosce nella cura per gli oggetti e i gesti, qualche mcguffin, nella direzione sapiente degli attori (osservate le mani parlare), nella dialettica tra vicinanza e distanza, corpi e cose, forme e contenuti. In una condizione di finta parità, Alma tiene lezioni di etica e morale, spiega Foucault e il panopticon; in questo senso il film è una sfida per conquistare l’epicentro del dispositivo, la torre dei sorveglianti che osservano i prigionieri circostanti. Chi ci riesce? Forse Alma, che insegna il paradosso di Ulisse secondo Arendt, ma ne riduce opportunisticamente la teoria a un guscio vuoto? O Maggie, vicaria di una generazione Z che finge di combattere gli stessi privilegi su cui si adagia? No, nessuno riesce davvero a occupare il centro del panopticon, nessun personaggio controlla gli altri nella partita di “Eva contro Eva“.
Ormai i sorvegliati, nel cinema contemporaneo, conoscono la cara e vecchia teoria: non si sottomettono più allo sguardo dell’Altro, ma lo ingannano astutamente, rimpiazzando la propria immagine con dei falsi simulacri. Quando tutto sembra precipitare, l’unico demiurgo in grado di sorvegliare e punire, giudicare e manovrare, è – e non può non essere – l’autore. Divertito e comodamente seduto nella sua torre panottica, Guadagnino ha l’ultima parola, sospende per un attimo la sua invisibilità e grida il “cut!” definitivo. Il cinema ha vinto la caccia.
A HOUSE OF DYNAMITE di Kathryn Bigelow (concorso)
Walter Benjamin scriveva che il cinema avrebbe fatto saltare con la dinamite il senso della dimensione spazio-temporale, nonché della relazione dell’uomo con la realtà. L’ultimo film di Kathryn Bigelow pende come una spada di Damocle ricoperta di dinamite: l’intelligence USA ha 19 minuti per salvare Chicago da un missile nucleare e il countdown viene ripetuto, nella sua scansione temporale, in sedi e punti di vista diversi. A House of Dynamite giunge in seguito ad altri ordigni cinematografici in balia del tempo: la corsa contro l’alba in Il buio si avvicina, il conto alla rovescia dell’anno nuovo in Strange Days, i disinnescatori in The Hurt Locker.
Ma nel 2025 Bigelow informa il suo spettatore dal principio che nessun eroe, soldato, ingegnere o diplomatico sarà in grado di fermare la bomba. «Not if. When», recita una tagline del film; non è importante se esploderà, ma quando. L’autrice di Point Break scandaglia quello spazio d’intervento tra l’ipotesi e l’evento, amplifica quei 19 minuti e li moltiplica in tre parti – anzi, variazioni sul tema – non tanto per frammentare i punti di vista in un Rashomon sulla parzialità del vero, ma per dichiarare, apoditticamente, la fine di quei punti di vista, cioè dell’America (e del suo cinema). Un’America che ha esaurito il suo tempo per “tornare grande” o rievocare battaglie di un passato illusoriamente glorioso.
Così come Zero Dark Thirty era la visualizzazione del fuoricampo di immagini che hanno segnato la storia, qui si parte dal monitor di un computer che mostra il collegamento in videocall dei piani alti del governo. Le tre parti sono l’una il controcampo dell’altra, sono i tentativi di colmare l’al di là di immagini virtuali e di dare corpo alle voci udite attraverso le innumerevoli chiamate (su tutti il Presidente che parla da uno schermo nero, presenza deacusmatizzata solo nella terza parte). Il desktop di un pc riceve su di sé e restituisce la proliferazione delle immagini, ma questo complesso reticolo di dispositivi, computer, telefoni e monitor non conduce ad alcuna soluzione.
L’unico schermo che necessiterebbe di un controcampo per evitare il crollo del Paese, cioè il radar che rileva l’orbita della bomba-fantasma, non giunge allo sguardo, non produce nessuna immagine “reale”. E si sa, vedere significa controllare, dunque individuare il nemico esterno. Perso nella fitta rete di numeri e media, ormai privi di valore se non quello di accumularsi rendendo illeggibile la realtà, il sistema operativo è incapace di vedere che, forse, il nemico è interno. L’unico “controcampo” possibile all’immagine virtuale del collasso è un’inquietante scenario finale di un mondo pieno di dinamite che si prepara ad accendersi.
L’ÉTRANGER di François Ozon (concorso)

Il vecchio logo della Gaumont introduce un (finto?) cinegiornale d’epoca che propaganda le “radiose” giornate dei cittadini francesi ad Algeri. Tra questi l’opaco e sonnolente Meursault, che non piange al funerale della madre e uccide “per caso” un arabo sulla spiaggia assolata. Il frammento documentario che apre la seconda versione cinematografica del romanzo di Camus dopo l’adattamento di Visconti, lungi dall’essere un vezzo stilistico alla Casablanca o Pépé le Moko, è la chiave per comprendere la rilettura di François Ozon. L’immagine realistica (ma non reale) del cinegiornale, con la sua pretesa di dire la verità sulla situazione coloniale, si rivela infatti più falsa del film di finzione che segue.
L’étranger mantiene la forza allegorica di Camus, ma in questa contraddizione propria dell’immagine filmica si ri-posiziona criticamente nei confronti del passato e si impone di dire il vero. Durante il processo-farsa, l’apatico protagonista rifiuta categoricamente di fingersi innocente e chiede al giudice (o al cinema?) «perché mentire?», mentre l’avvocato grida esasperato che «tutto è vero e nulla è vero». Perché camuffare il brutale imperialismo ad Algeri? Perché credere che il cinema dica la verità? Lo sguardo di Ozon si fa così anticolonialista e mira a problematizzare la fonte stessa del romanzo.
Pur restando focalizzato sulla figura dell’inetto, il film va oltre l’esistenzialismo: illumina il rapporto impari tra algerini e francesi, lo squilibrio di potere tra loro – si pensi alle armi: l’arabo ha un coltello, mentre il francese può difendersi con una pistola -, la violenza del linguaggio (gli algerini sono chiamati “indigeni”), il divieto di accesso agli arabi nei cinema, luogo riservato al torpore di europei dormienti. Uno di questi arabi senza nome è ucciso par hasard da Meursault, accecato dal sole. Una scena in cui l’indugiare sui corpi, resi languidi da caldo e sudore, insinua una sensualità omoerotica che rievoca Genet e Fassbinder.
Sostenuto da una fatalità quasi langhiana, il film non concede redenzione né punizione, ma conferma la complicità e la condanna universali, almeno per gli oppressori. Neanche l’amore per una donna concede la grazia bressoniana attraverso le grate della prigione: a separarli, tra due cancelli, c’è il vuoto in cui si radica l’assurdo. Nel contemporaneo, il film non può che concludersi sulla tomba dell’arabo, la vittima di cui, finalmente, si rivendicano un nome e un cognome. Che sia lui lo straniero del titolo, estromesso da altri nella propria terra?
LA GRAZIA di Paolo Sorrentino (concorso)
Il cielo sopra il Quirinale è attraversato dalle frecce tricolori, le cui scie verdi, bianche e rosse si dissolvono rapide in un’unica nube grigia. In questa zona sfumata si colloca il Presidente della Repubblica Mariano De Santis, protagonista dell’atteso ultimo film di Paolo Sorrentino, che ritorna a immaginare le vite private del potere dopo il giovane Papa e il nuovo, Il divo Andreotti, Berlusconi e Loro. Il Presidente qui è inventato ex novo, è la declinazione di figure passate in un presente alternativo (o un futuro progressista), l’astrazione di un ruolo e la concretezza dell’individuo; forse per questo è più umano delle maschere grottesche ispirate a veri politici.
Premiato con la Coppa Volpi, Toni Servillo traduce sul volto e l’anima della senilità le grandi coppie oppositive del suo cinema: vecchiaia e giovinezza, sacro e profano, uomo e icona, stasi e movimento, oblio e memoria. La zona è grigia perché, a pochi mesi alla fine del suo mandato, l’anziano ex giurista deve affrontare due questioni delicate: la legge sull’eutanasia e la concessione di due grazie. A spronarlo dalla sua indecidibilità e mancanza di coraggio (un po’ da ex democristiano), c’è la figlia Dorotea, esperta di diritto.
Nonostante venga chiamato da tutti “cemento armato”, per la solidità delle sue idee e il profondo senso di responsabilità, Mariano sogna l’assenza di gravità, perché sa che la grazia è “la bellezza del dubbio” nella ricerca della verità, nel chiedersi di continuo di chi sono i nostri giorni. L’efficienza di un capo di Stato – o della Chiesa – sta nella capacità di destreggiarsi tra l’universalità e la singolarità, tra la legge e l’amore. Nella sua vita privata, quasi tutta in interni istituzionali, c’è dunque sia la mondanità, con i piedi ben saldi a terra, sia la leggerezza e la bellezza della solitudine. La prima è contenuta da uno stile insolitamente misurato per l’autore partenopeo, specie nei dialoghi, nei confronti tra padre e figlia, nelle sobrie gerarchie del governo; la seconda emerge nei consueti virtuosismi, nell’eccesso strabordante.
Ed è in questi momenti che il tempo rallenta, lo spazio assume i contorni di una poesia kitsch che – almeno da È stata la mano di Dio – dimostrano un autore pervenuto alla (nuova) maturità, che sa guardarsi con distacco e ironia attraverso i propri alter ego. La tempesta improvvisa, la coreografia pop e il rap di Guè, la lacrima dell’astronauta che si avvicina allo schermo sono solo alcuni esempi di un immaginario che, tra la stanchezza e la noia dell’andropausa, ha forse raggiunto la grazia. Perché, in fondo, la grazia non è altro che l’esitazione di uno sguardo.
di Ludovico Franco