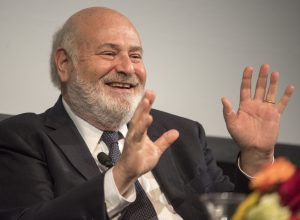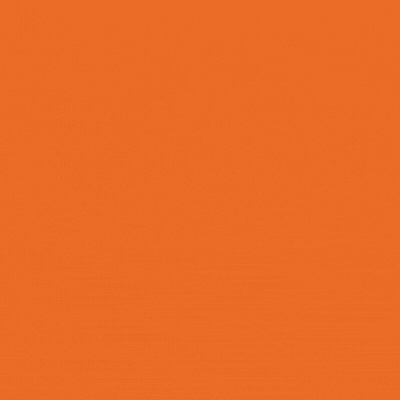Nell’ultima settimana, in seguito alla cerimonia dei David di Donatello 2025, Vermiglio di Maura Delpero è tornato all’attenzione di spettatori e critici, dopo la vittoria del Leone d’argento alla Mostra internazionale di Venezia e l’uscita nelle sale italiane lo scorso settembre. Questo perché il film ha raggiunto due importanti traguardi. È stato innanzitutto protagonista della serata, ottenendo sette David su quattordici candidature, tra cui il prestigioso riconoscimento al miglior film, conteso con Berlinguer – La Grande Ambizione di Andrea Segre, Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, L’arte della gioia di Valeria Golino e Parthenope di Paolo Sorrentino.
Inoltre, Vermiglio ha segnato un nuovo capitolo nella storia dei David di Donatello, giunti alla loro settantesima edizione: Maura Delpero, infatti, è stata la prima donna premiata con la statuetta per la miglior regia. La regista ha portato sul palco dei David l’attenzione sul cinema al femminile, per altro ben rappresentato anche da altri film candidati, e sul cinema del reale, punto di partenza fondamentale per il suo percorso, che si augura continui a ritagliarsi spazio e notorietà in Italia.
Le stagioni di una comunità e la vita di montagna
Nella penombra della notte, tre sorelle dormono una di fianco all’altra. I loro volti semplici, il giaciglio appena giusto, la percezione di totale innocenza e candore: tutto ci porta in un altro tempo. Ci porta a Vermiglio, nel gelido inverno del 1944. La camera si sofferma per qualche istante sulle ragazze, per poi mostrarci altri letti, altri fratelli. È così che, all’inizio del film, entriamo nella quotidianità domestica della famiglia Graziadei, attraverso una serie di inquadrature fisse che, per la loro forza contemplativa, potrebbero essere dei quadri di Vermeer.
Lo stile si distingue subito per la fotografia di Michail Krichman, che costruisce un gioco delicato di chiaroscuri e colori freddi, creando una sensazione di gelo quasi tangibile, ancora più impattante nei successivi campi lunghi sulla casa immersa in uno scenario di montagna innevato. È percepibile lo sguardo incantato della regista verso i luoghi raccontati, dove risiedono parte delle sue origini. Il tempo a Vermiglio scorre lentamente: con questa scelta coraggiosa e oggi controcorrente, Maura Delpero delinea la vita di una comunità d’antan, scandita dall’alternarsi delle stagioni, fino ad arrivare all’estate. È un racconto che, per l’ambientazione umile quanto per il realismo poetico, ricorda il cinema umanista di Ermanno Olmi, quasi un omaggio al suo L’albero degli zoccoli del 1978.

In Vermiglio, la Seconda Guerra Mondiale è una presenza fuoricampo, di cui di tanto in tanto arrivano notizie. In qualche modo, però, il conflitto è destinato a turbare gli equilibri del piccolo paese trentino, quando vi giunge un soldato disertore di origine siciliana, Pietro (Giuseppe DeDomenico). Di fronte al trambusto generato da questo arrivo, Cesare Graziadei (Tommaso Ragno), capofamiglia e maestro del villaggio, si lascia andare ad una riflessione su come, se tutti i soldati fossero disertori, forse non esisterebbe la guerra. Dietro allo slancio di Cesare, alle sue parole figlie del tempo, Maura Delpero inizia ad intessere il discorso profondamente antimilitarista che silenziosamente caratterizza l’intero film. La sorella più grande della famiglia Graziadei, Lucia (Martina Scrinzi), si innamora infatti di Pietro e ciò dà origine ad uno dei fili narrativi principali di Vermiglio.
Silenzi e ritratti femminili
Forse per la ferrea educazione cattolica, forse per il carattere introverso degli abitanti di montagna, le emozioni in Vermiglio non vengono mai gridate: i sentimenti si delineano attraverso piccoli gesti, sguardi timidi ed innamorati, parole bisbigliate all’orecchio nella notte, silenzi. In questa direzione si sviluppa anche il suono, in primis con la scelta di far esprimere i personaggi in dialetto, che insieme all’ambientazione storica ha richiamato per alcuni critici il neorealismo italiano. I momenti di silenzio, o meglio di leggero rumore quotidiano, sono presenti e ben dosati: a questi si alternano le musiche, interamente diegetiche, che rappresentano un’espressione della cultura del villaggio. Più delle canzoni da festa, colpiscono le ninnananne che tornano ciclicamente a riecheggiare in casa per i bambini della famiglia Graziadei. Sono canti quasi sussurrati da voci femminili, parentesi poetiche tra le paure di una maternità minacciata dalla povertà, tradizioni trasmesse di madre in figlia.
Maura Delpero ha iniziato ad esplorare il tema della maternità già nel suo primo film, Maternal, uscito nel 2019 ed ora disponibile su RaiPlay. Ambientato in una casa famiglia per ragazze madri di Buenos Aires, il lungometraggio anticipa alcuni punti cardine di Vermiglio, come l’obbligo di sottostare a regole rigide ed a figure autorevoli, i tormenti di giovani donne che non si sentono pronte a diventare madri, la sorellanza femminile come forma di resistenza. La regista crea spesso dei personaggi grigi, contraddittori nella loro umanità ed espressione del contesto a cui appartengono.

Nel caso di Vermiglio, Cesare Graziadei (Tommaso Ragno) si presenta come un uomo colto, con la missione dell’insegnamento e dalle vedute ben più ampie dei suoi compaesani; allo stesso tempo, però, è un marito che impone con intransigenza le proprie decisioni alla moglie, quasi sempre ridotta al silenzio. Proprio nei ritratti delle figure femminili Vermiglio trova la sua anima più struggente: dalla caratterizzazione delle donne semplici di paese, casalinghe e spesso madri di soldati, fino al racconto dei sogni delle tre figlie della famiglia Graziadei. Mentre Lucia (Martina Scrinzi) spera di trovare la felicità nel matrimonio, le due più piccole, Ada (Rachele Potrich) e Flavia (Anna Thaler), si impegnano al massimo dietro ai banchi di scuola, mentre l’ansia di guadagnarsi l’opportunità di continuare gli studi si mescola ad una difficile scoperta di sé. Le tre sorelle raffigurate nella prima inquadratura si caricano man mano di caratteristiche diverse e complementari, molto indicative della condizione femminile nelle piccole realtà degli anni ‘40, ma capaci anche di interrogare sul loro retaggio nell’Italia di oggi.
di Chiara Zoja