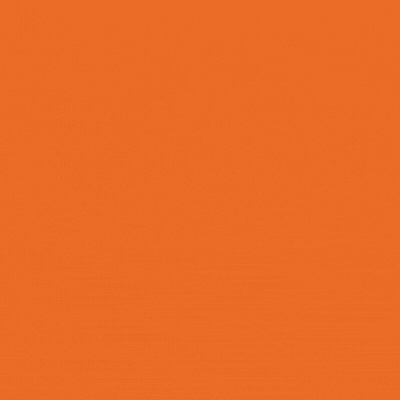Nel suo saggio Elogio della follia, Erasmo da Rotterdam descrive la Pazzia come una forza utile alla felicità dell’uomo. Dalla notte dei tempi la storia della cultura ha fluttuato continuamente tra l’attrazione e la repulsione per la follia. Sia che si tratti di passioni distruttive che travolgono personaggi come Fedra, sia che si tratti di un’indagine terrorizzante nel cuore della schizofrenia umana come nel caso di Edgar Allan Poe (da recuperare le trasposizioni cinematografiche di Roger Corman), la storia del cinema ci lascia ugualmente una grande lezione sulla follia. Pensiamo per un momento in quanti film si incontrano personaggi che oscillano continuamente sul pendolo tra realtà e pazzia. La mole è tale da rendere impossibile anche solo una generica citazione di tutte le opere, dunque una selezione non può che essere necessaria e, naturalmente, soggettiva. Siete invitati ad addentrarvi con noi nel labirinto della follia in celluloide, alla ricerca di alcune direttrici fondamentali che hanno caratterizzato la sua rappresentazione nella Settima Arte.
Difficile definire la follia: è semplicemente una condizione mentale, clinica e patologica di forte anomalia rispetto al resto? O forse una caratteristica ontologica della natura umana? Un impulso istintivo? O una devianza di tipo socio-culturale? Qualunque cosa essa sia, meglio affidarci inizialmente all’aiuto datoci dalla psicoanalisi per evitare di usare il termine a sproposito. È infatti fondamentale sottolineare come il cinema sia forse l’arte che più di ogni altra ha stretto un legame indissolubile con la psicoanalisi. D’altronde, nel 1895, quando i fratelli Lumière tennero la prima proiezione pubblica a Parigi, a Vienna Freud eseguiva la prima interpretazione di un sogno. Fin dai primi decenni del Novecento, il cinema ha visto la psicoanalisi come soluzione a crisi depressive o stati mentali instabili, spesso bollati subito come casi di pazzia dalla società. Tra i primi ad affrontare esplicitamente la follia e la sua cura attraverso una terapia ci fu il tedesco G. W. Pabst con I misteri di un’anima nel 1926. Negli anni Venti l’interesse per la psicologia è vivo più che mai, come dimostrano gli innumerevoli romanzi del periodo, La coscienza di Zeno su tutti. Come non ricordare poi il maestro che più di tutti ha captato la lezione di Freud, Alfred Hitchcock, affrontandola costantemente in ogni sua pellicola, sia esplicitamente che implicitamente per via di simbologie. Capolavori immortali come Io ti salverò (1945), La donna che visse due volte (1958), Psycho (1960), Marnie (1964) sono in questo senso paradigmatici. Il primo di questi è ambientato nel contesto di una clinica psichiatrica in cui, cercando di trovare il colpevole di un omicidio, si esplora il labirinto oscuro del passato del protagonista. Ma uno dei titoli che maggiormente vede il metodo freudiano come strumento di guarigione è La fossa dei serpenti (1948), che ispirò concreti cambiamenti nelle istituzioni psichiatriche, per tentare di migliorare le condizioni dei pazienti.

Ma non sempre il ricovero in una clinica può migliorare lo stato di follia. Anzi, spesso è proprio la causa primaria di una lenta discesa nella pazzia di individui ritenuti inadatti, quindi pazzi, o che lo diventano perché inghiottiti nel vortice dell’ingiustizia di molti sistemi malati. Lo dimostra bene Il corridoio della paura (1963) di Samuel Fuller, in cui un giornalista ambizioso si finge malato per farsi ricoverare in una clinica dove vuole indagare su un delitto, finendo quasi pirandellianamente per diventare la parte del folle che doveva recitare. Un capolavoro mai troppo ricordato, ma che ha ispirato tantissimi registi come Scorsese con il suo Shutter island o per certi versi la serie tv American horror story: Asylum. Ma la denuncia più celebre del trattamento inumano riservato ai pazienti ospitati nei manicomi statali arriva con Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) di Milos Forman. Il comportamento anticonformista e folle del protagonista interpretato da Jack Nicholson mostra anche la chiusura mentale di una società che non accetta al suo interno stati di malattia psicologica, tanto da abusare di metodi di terapia aggressivi come l’elettroshock. L’impossibilità di opporsi all’autorità e al potere ritorna in un recente e interessante film di Steven Soderbergh, Unsane (2018) in cui la protagonista finisce in una spirale kafkiana di controllo e manipolazione da parte di una clinica in cui si fa ricoverare di sua spontanea volontà, per poi non riuscire più a dimostrare di essere l’unica sana in un ambiente malato. Situazione che colpisce anche la protagonista di un gioiellino dei b-movies, Mi chiamo Giulia Ross (1945), dove una donna viene rapita da un gruppo di nevrotici e manipolata per farle credere di essere una ricca schizofrenica. Personaggi-marionette modellati da gerarchie di potere si trovano spesso nella storia del cinema, come rivela Angoscia (1944). Qui troviamo una Ingrid Bergman che viene spinta alla pazzia dal marito che vuole arricchirsi, un tipo di fabula che poi avrà ampio seguito in moltissimi film successivi. Qualcosa di simile accade a Mia Farrow in Rosemary’s baby (1968), che vede l’impossibilità di distinguere la follia dalla realtà sia per i personaggi, sia per gli spettatori, che fino alla fine non sanno se credere alle paranoie di una donna incinta che si ritiene vittima di una setta satanica. Il regista Roman Polanski ha spesso affrontato magistralmente il tema della crisi di identità vissuta da uomini e donne in bilico tra la malattia mentale e l’impossibilità di vivere la realtà, come in Repulsion (1965) e in L’inquilino del terzo piano (1976). Il perturbante emerge continuamente per l’ambigua immedesimazione tra lo spettatore e lo stato di follia pura vissuto dai personaggi. Talvolta accade che il punto di vista sia proprio quello della follia, come nel caso dell’emblematico Il gabinetto del dottor Caligari (1920): per tutto il film siamo proiettati nella visione deviata del protagonista, che soltanto alla fine scopriamo essere il paziente di una clinica. Egli infatti distorce e rielabora nella sua mente le persone che lo circondano nella realtà come in un terribile incubo: il folle Dottor Caligari non è altro che il suo psichiatra e gli altri personaggi sono tutti pazienti ricoverati con lui. Questo pilastro del cinema espressionista tedesco dà anche avvio alla tradizione del cinema horror, confermando dei veri e propri archetipi, come gli omicidi in serie.

Spesso nella storia del cinema la pazzia è associata a una follia omicida, talvolta con minore interesse per lo scavo dello stato psicologico (come nel caso dei film slasher quali i vari Non aprite quella porta, Halloween, Venerdì 13…), talvolta con un’attenta analisi della condizione di schizofrenia e malattia mentale. A questo secondo gruppo appartengono film immortali come M – il mostro di Dusseldorf (1931) di Fritz Lang, che nella crisi della Repubblica di Weimar esplora i dilemmi morali e sociali attorno ad un assassino seriale di bambini, analizzato in modo umano e audace per l’epoca. Impossibile non parlare di Psycho (1960), che per quanto riguarda la follia omicida sul grande schermo è il massimo esempio. Come già detto, Hitchcock e la psicoanalisi sono sempre legati indissolubilmente e in questo caso lo stretto rapporto è chiarito sin dal titolo: è la psiche ad essere protagonista assoluta della storia, ma di una mente malata e complessa, che non riesce a tenere sotto controllo la sua dissociazione identitaria e le conseguenti pulsioni omicide. Ma un po’ come Norman Bates, “tutti qualche volta perdiamo un po’ la testa”. Brian De Palma ha fatto sua la lezione del maestro inglese e l’interesse per la pazzia in moltissimi film (Le due sorelle, Ossessione…), ma in particolare con Vestito per uccidere (1980) ci mostra in modo quasi ironico e tipico del suo cinema postmoderno uno psichiatra che di professione fa il folle assassino. Dello stesso anno del capolavoro di Hitchcock è L’occhio che uccide, che, oltre a farci immedesimare con le sofferenze del folle omicida protagonista, è una magnifica riflessione sul mezzo cinematografico stesso: il serial killer uccide le sue vittime alla ricerca del terrore puro dei loro sguardi nel momento in cui vedono la morte in viso. Spesso l’arma privilegiata degli assassini in celluloide è un’ascia affilata, come mostra per esempio il b-movie 5 corpi senza testa, dove Joan Crawford interpreta una donna che uccide marito e rispettiva amante, presa da un raptus di follia, per poi assistere alla continuazione della scia di sangue a colpi di ascia, di cui però non si ha la certezza che ne sia l’artefice. E da questa scia di sangue non si poteva non giungere ad un film che definire pietra miliare sarebbe riduttivo: Shining (1980) di Stanley Kubrick. Il perturbante e la lenta discesa nella pazzia trovano fissa dimora all’Overlook Hotel, dove per scopi lavorativi l’isolamento a lungo termine (O forse i fantasmi? O l’eterno ritorno del passato?) spinge il caro padre di famiglia Jack Torrance a voler fare a pezzi moglie e figlioletto, al culmine di una lentissima caduta nello squilibrio mentale. Per chiudere questa piccolissima parentesi sulla follia omicida, è giusto ricordare un film di cui purtroppo si parla poco: Bersagli (1968), opera prima di Peter Bogdanovich. Nel banale della più normale quotidianità di una famiglia americana qualcuno perde il senno e decide di compiere una strage degli innocenti armato di fucile. Vi ricorda qualcosa? Il film indaga lo scontro tra l’orrore reale e l’orrore fittizio, dato che seguiamo la storia di un attore che in passato era una star dell’horror (non a caso interpretato da Boris Karloff) e la carneficina finale avviene proprio in un drive-in che proietta un film dello stesso attore. Un’opera fondamentale per capire un certo tipo di Stati Uniti del 1968 (da sottolineare il fatto che il protagonista è reduce del Vietnam), dove l’era del terrore di mostri e fantasmi è resa obsoleta da quello che è l’orrore più grande: la realtà di ogni giorno.

Nella storia del cinema albergano poi moltissimi personaggi che si manifestano folli agli occhi del resto della società. Donne e uomini che spesso hanno solo bisogno di aiuto, per poter calmare stati psicologici alterati, crisi depressive o mistiche. Nella maggior parte dei casi si tratta di figure femminili complesse e turbate, come quella ritratta da John Cassavetes in Una moglie (1974), dove una grandiosa Gena Rowlands interpreta una madre di famiglia emotivamente fragile e instabile. L’etichetta di “pazza” le viene affibbiata innanzitutto dal marito, che la fa ricoverare in una clinica invano, poiché non è di uno psichiatra che la donna ha bisogno, ma di affetto e cura. Una madre di famiglia molto simile appare in Paura della paura (1975) del compianto R. W. Fassbinder. Il peso e la responsabilità della famiglia sulle spalle della protagonista la portano a stati di follia sempre più evidenti, con comportamenti bizzarri giudicati aspramente dagli altri invece di venire colti come gridi d’aiuto. Tuttavia, è soprattutto nella filmografia di Ingmar Bergman che incontriamo numerose donne mentalmente instabili: in particolare con Persona (1966), la follia viene scambiata per sanità e viceversa, in quanto l’afasia della protagonista (interpretata da Liv Ullmann) è una scelta cosciente per amplificare l’incomunicabilità e il rifiuto a recitare, sul palco (la donna è un’attrice teatrale) e nella vita. Liv Ullmann apparirà anche in L’immagine allo specchio (1976), dove la follia scaturisce da traumi e terrore di fronte alla vita. Come in uno specchio (1961) mette invece in scena il dramma di una famiglia stretta attorno alla sofferenza psichica della protagonista, lacerata dall’interno da allucinazioni mistico-religiose che le procurano frequenti attacchi. Allontanandoci da questi titoli drammatici e forti, consideriamo ora una commedia classica hollywoodiana, Harvey (1950). James Stewart è un uomo bizzarro quanto adorabile che crede di avere un coniglio gigante per amico. Per una serie di equivoci, la sorella che vuole internarlo in clinica è considerata la matta tra i due.

Nessuno ha detto che la pazzia deve essere soltanto individuale: sono molti e inquietanti i casi di follia collettiva che infestano la storia del mondo. Un episodio molto radicato nell’immaginario culturale accadde in un convento di monache a Loudun nel 1634. Quella che era considerata una possessione demoniaca di massa era in realtà una forma di isteria derivata soprattutto da frustrazione sessuale e passò alla storia come “il caso dei diavoli di Loudun”, e fu fonte di ispirazione per due titoli molto particolari: Madre Giovanna degli Angeli (1961) e I diavoli (1971). Il primo è un film polacco che rende perfettamente il clima di follia che attacca la mente delle delle monache e fa vacillare la fede del sacerdote esorcista. Il secondo è forse IL capolavoro di Ken Russell, che scatena in tutta libertà ogni barocchismo nella messa in scena con trovate a tutti gli effetti folli, gli zoom improvvisi, i costumi e le scenografie. Permeato da un profondo senso anticlericale che non sembra dimenticare la lezione di Bunuel o di La stregoneria attraverso i secoli. Da guardare (rigorosamente in versione integrale) anche per le recitazioni di Oliver Reed e Vanessa Redgrave.

Se I diavoli è folle sia per quanto riguarda il contenuto che la sua messa in scena, i prossimi titoli sono dei veri e propri tour de force per lo spettatore, inghiottito in un universo ai limiti della pazzia allo stato puro. Su tutti Possession (1981). Basterebbe la sequenza di Isabelle Adjani nella metropolitana (di seguito il link) per elevare questo film a manifesto della follia cinematografica. Visionario e nichilista, per certi versi lovecraftiano, è in fin dei conti un’indagine mostruosa e allucinante sull’esistenza umana, specialmente sulla vita di coppia e i suoi demoni. Sam Neill e Isabelle Adjani (che vinse il premio come migliore attrice a Cannes) raggiungono picchi di follia che rimangono conficcati come pugnali negli occhi dello spettatore. Il film ha l’aspetto di un vero e proprio sfogo isterico e violento. Insomma, Scene da un matrimonio di Bergman visto con lo sguardo patologico di un incubo. David Lynch nel 2006 l’ha definito “la pellicola più completa degli ultimi trent’anni”. Ed è proprio con il genio di Lynch che incontriamo altre figure ugualmente folli: da Frank (Dennis Hopper), il folle perverso e violento di Velluto blu, a Nikki (Laura Dern) di Inland Empire, nel suo cinema c’è sempre almeno un personaggio o un elemento rappresentante la pazzia. Tuttavia è nel suo film d’esordio che troviamo il nucleo fondamentale e primordiale della follia nella sua poetica: basta guardare Eraserhead (1977) per rendersene conto alla perfezione. Forse è proprio la natura sperimentale della pellicola a renderlo ancora oggi cristallino nel trasmettere le ansie inconsce e più perturbanti dell’autore. Kubrick lo proiettava di continuo sul set di Shining per trasmettere il senso di inquietudine e pazzia al resto della troupe. Arriviamo ora ad un titolo che letteralmente ci fa sprofondare nella bocca della follia (per tradurre il titolo originale In the mouth of madness), cioè Il seme della follia (1994) di John Carpenter. Troviamo ancora una volta il grandissimo Sam Neill, qui paziente ricoverato in psichiatria, che rievoca il suo viaggio quasi dantesco, ma chiaramente ispirato agli scritti di H. P. Lovecraft (specialmente Alle montagne della follia), nelle viscere più visionarie e soprannaturali. L’incapacità di distinguere finzione letteraria e realtà diventa pressoché impossibile. I libri qui fanno impazzire le persone e le mutano in creature demoniache, generando vere e proprie follie omicide collettive. E non si può non pensare anche a E tu vivrai nel terrore… l’Aldilà di Lucio Fulci.

Giungiamo ora ad affrontare gli ultimi titoli, in cui incontriamo vere e proprie donne folli, alienate e soprattutto violente. Il primo di questi è Femmina folle (1945), titolo italiano un po’ ridicolo e riduttivo rispetto all’originale Leave her to heaven. Infatti questo piccolo capolavoro dei mélo più noir di Hollywood ci narra la vicenda estremamente complessa a livello psicologico di una donna a tutti gli effetti pazza di gelosia, tanto da uccidere il figlio che porta in grembo e in seguito sé stessa. Riduttivo quindi inscrivere una mente così labirintica soltanto nell’aggettivo “folle”. Purtroppo nella vita l’attrice Gene Tierney, qui protagonista, soffriva davvero di forti crisi depressive e salute mentale, tanto che per un certo periodo sparì dalle scene. Una figura materna che divora i propri figli nutrita dall’odio per suo marito si trova poi in Brood (1979) di David Cronenberg, in cui la protagonista genera creature mostruose che uccidono secondo il suo volere quelli che dovrebbero essere i suoi più cari famigliari. Nel 1962, con Che fine ha fatto Baby Jane?, Bette Davis ci regala una delle più belle e folli rappresentazioni della lenta discesa nella pazzia, in questo caso spinta dall’alcolismo, dall’invidia e dalla caduta di una stella del vaudeville un tempo grande e luminosa. Un po’ come la Norma Desmond interpretata da Gloria Swanson in Viale del tramonto, per capirci, ma molto più sadica ed estrema. Baby Jane, cresciuta, si diverte ad impedire la vita alla sorella, immobilizzata su una sedia a rotelle, sottoponendola ad ogni tipo di crudeltà, dall’isolamento ai pranzi meno invitanti possibili a base di ratti morti. La danza finale di Bette Davis sulla spiaggia dopo che ha lasciato morire la sorella è destinata a rimanere nella storia del cinema come una grande analisi dell’alienazione, specialmente quella generata dalla brama di successo. Ritornando a Viale del tramonto, abbiamo un finale molto simile dove la ex diva del muto protagonista scambia i giornalisti e i poliziotti (accorsi per l’omicidio da lei commesso) per gli operatori di un prestogioso studio cinematografico.

Con Il buio della mente (1995) di Claude Chabrol incontriamo due grandiose attrici, Isabelle Huppert e Sandrine Bonnaire, che interpretano due donne con gravi problemi psicologici legati a traumi passati che, un po’ per gioco e un po’ per invidia sociale, massacrano l’intera famiglia dove una delle due faceva la domestica. Una cerimonia di sangue per punire la famiglia borghese fintamente felice. Concludiamo ora con un vero e proprio cult: Misery non deve morire (1990). Cosa fareste se vi capitasse di salvare da un incidente stradale il vostro scrittore preferito? Annie Wilkes (Kathy Bates, che vinse l’Oscar come migliore attrice), esperta infermiera e pazza omicida, lo terrebbe rinchiuso nella sua casetta isolata di montagna e lo costringerebbe a scrivere un nuovo romanzo sotto la sua supervisione. E lo scrittore deve ascoltare i suoi consigli di appassionata lettrice, se non vuole rimetterci altre ossa, oltre a quelle dei piedi. Rimane ancora oggi uno dei migliori adattamenti cinematografici della letteratura di Stephen King. Quando le amorevoli cure della più grande ammiratrice diventano una gabbia da cui è impossibile fuggire, meglio abbandonare la scrittura e darsi all’uncinetto.

Giunti alla fine di questo lungo, seppur riduttivo e breve percorso, sulla follia al cinema nelle sue varie manifestazioni, speriamo che la pazzia nascosta negli angoli più bui della vostra mente sia stata stimolata da qualcuno di questi titoli, alcuni conosciuti, altri meno, altri ancora dei veri e propri cult irrinunciabili. Non resta che augurare una buona, pazza, pazza, pazza visione a tutti!
di Ludovico Franco