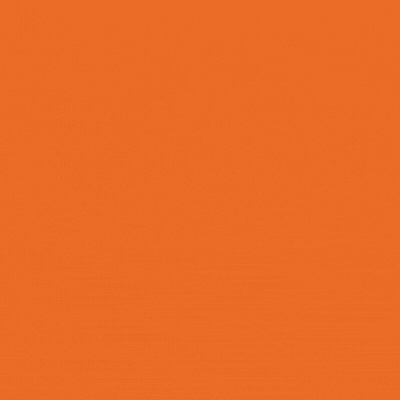C’è stata un’epoca in cui i dipendenti regionali, in Valle d’Aosta, erano 400, e quelli della miniera e del suo indotto, compresa l’acciaieria di Aosta, erano 5000. La tendenza si è invertita, e lo sviluppo della regione è passato attraverso altre strade. La miniera, chiusa definitivamente nel ’79, è ormai un ricordo.
Ieri, in occasione della Giornata Nazionale delle Miniere, Fondation Gran Paradis ha organizzato delle visite guidate al Villaggio Minatori, in compagnia degli ultimi minatori di Cogne.
Ad inaugurare la prima visita l’ex sindaco Osvaldo Ruffier, con 31 anni di miniera alle spalle. L’immagine che tutti abbiamo della miniera, mutuata da film e romanzi, è quasi infernale: buio onnipresente, esplosioni, fatica, umidità, claustrofobia. Si trattava effettivamente di un lavoro estremamente duro, ma lo sfruttamento della miniera, oltre ad aver impresso un’impronta indelebile nel territorio, nella storia e nelle coscienze dei valdostani, ha regalato a Cogne e alla regione un benessere altrimenti impossibile, fin dai tempi di Cesare Grappein.
Sopra Cogne, a 2500 metri di altitudine, gli edifici di Colonna raccontano una storia dai tratti epici. “Ho lavorato con persone da tutta Italia, da ogni provincia. Prima della guerra c’erano i veneti, poi sono arrivati i valdostani, i calabresi, e infine, nell’ultimo periodo, moltissimi sardi” ha raccontato Ruffier. “A Colonna, fino al ’63, dormivano in un solo caseggiato, in camerate da 12 o da 24 letti. Qui al Villaggio minatori, invece, c’erano tre alloggi separati, uno per turno, in modo che i lavoratori non si infastidissero a vicenda coricandosi e svegliandosi ad ore diverse”. La vita, prima delle conquiste operaie, non era delle più facili, e a pesare era soprattutto l’isolamento. “I minatori stavano a Colonna 12 mesi, con 12 giorni di ferie all’anno. Niente famiglia, niente mogli, addirittura niente donne. Per il resto, avevano, oltre a mensa e dormitori, lo spaccio, il calzolaio, il barbiere, il cinematografo, la pista per le bocce, e si distraevano, nella bella stagione, facendo qualche passeggiata. C’è chi l’ha fatto per 20 anni”. Colonna rivive, tra l’altro, nel film documentario del 1938 “Le miniere” girato da Marco Elter, fratello del direttore delle miniere Franz, proiettato per i visitatori.
Nella piazzetta interna del villaggio dei minatori fa ancora bella mostra di sé il trenino, la vecchia locomotiva con alcuni vagoni. La ferrovia del Drinc serviva a trasportare il materiale da Cogne ad Acqua fredde, a Gressan. L’attuale museo dei minatori, una versione limitata di quello che dovrebbe sorgere un giorno, espone le tute e gli strumenti da lavoro originali, e spiega, attraverso una serie di pannelli, come funzionava la miniera. A colpire l’immaginazione sono soprattutto gli attrezzi, tra i quali spiccano chiavi inglesi lunghe un metro, talmente pesanti che una persona normale le solleva con difficoltà: ogni gesto, in miniera, era inevitabilmente carico di fatica, e strettamente necessario.
Sottoterra il lavoro non mancava, ma le condizioni richiedevano una certa capacità di adattamento. “La temperatura era di 6, 7 gradi tutto l’anno, d’inverno era meglio, c’era meno umidità. L’aria non mancava, in una montagna tutta forata c’è abbastanza ricambio. Erano turni da 100 persone, non tutti stavano allo stesso livello, si lavorava in una decina di livelli contemporaneamente, scavati con l’esplosivo. E oltre ai minatori c’erano tantissimi manovali impiegati in molte mansioni”. Osvaldo Ruffier ha visto la vita in miniera cambiare. “So che all’inizio i minatori non avevano neppure il casco, poco dopo il mio arrivo sono arrivate le prime giacche impermeabili. Fino al ’48 il materiale è stato caricato a mano, poi sono arrivate le prime pale meccaniche ad aria compressa, poi ad acqua, e infine le autopale. Ma i nuovi arrivati, per i primi 15 giorni, dovevano comunque caricare a mano, per capire cosa significava essere un minatore”.
E la luce? Negli ultimi anni si usavano le lampade a batteria, ma fino a metà anni ’60 si utilizzavano le lampade a carburo, caricate con acqua e carburo di calcio, sotto forma di piccole pietre, che consumandosi diventavano polvere. Ognuno aveva la sua, che illuminava una stretta porzione davanti a sé. “Era raro, ma poteva capitare che ti si spegnesse la lampada, e che ti ritrovassi al buio nel cunicolo, da solo. A quel punto battevi con il piede per seguire il contorno della rotaia, o del tubo dell’aria compressa, e avanzavi piano, alla cieca, cercando di non sbattere la testa alle biforcazioni, chiamando i compagni”. L’incubo di ogni claustrofobico. Le miniere di Cogne erano un vero labirinto, composta da livelli che correvano paralleli, ogni sei metri, per cinquecento metri sotto terra, anche se gli ultimi duecento metri sono stati solo tracciati, ma non sfruttati. Nelle viscere della terra ci sono ancora 3 milioni di tonnellate di magnetite purissima, la migliore del mondo assieme a quella svedese. Con il ritmo di estrazione utilizzato negli ultimi anni, ci sarebbe stato lavoro per altri 15 anni.
A Cogne in tutte le famiglie c’era qualcuno che lavorava in miniera, come minatore, operaio o impiegato. “Mi svegliavo alle quattro per attaccare il turno delle 6” ha raccontato ancora Osvaldo Ruffier. “Scendevo da casa, a Gimillian, aspettavo anche per 40 minuti la benna che ci trasportava, 12 alla volta, a Colonna, mi cambiavo, timbravo e aspettavo con gli altri i compagni che finivano il turno, per darci il cambio. Quando uscivano loro entravamo noi. Alle 14 avevo finito, facevo la doccia, mangiavo in mensa e poi aspettavo la benna per il ritorno”.
In mezzo c’erano le gallerie, il buio, il freddo e la fatica, ma Ruffier ci si sofferma poco, quasi con pudore. Il lavoro all’epoca c’era, bastava rimboccarsi le maniche. Anche chi non era minatore, a Cogne, non era certo "choosy", e si svegliava ugualmente alle 4 per mungere le vacche.