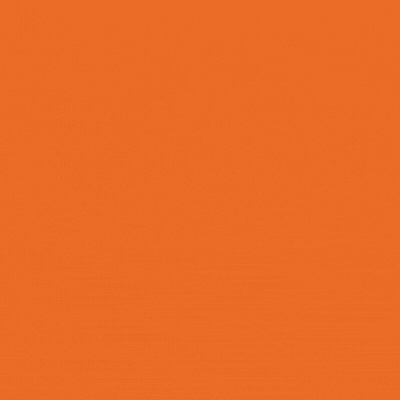La parola “amaranto” deriva dal greco e significa “che non appassisce, che non muore.”
Esistono almeno sessanta specie diverse di amaranto, appartenenti all’omonima famiglia (Amarantacee); si tratta quindi, come nel caso del grano saraceno e della quinoa, di uno pseudocereale. Le specie che risultano essere le migliori produttrici di semi commestibili sono originarie del Centro e del Sud America (cruentus e hypochondriacus) e dell’India (caudatus).
In Occidente, dove crescono spontanee alcune varietà come il graecizans e il retroflexus, questa pianta è sempre stata utilizzata ad esclusivo uso ornamentale.
Era noto agli antichi Greci per la bellezza e la lunga vita del suo fiore. Risale ad allora l’usanza di considerare l’amaranto simbolo di amicizia eterna. Esopo gli dedicò una delle sue favole a sfondo morale, “La rosa e l’amaranto”. Pare fosse tra le piante sacre alla dea Artemide. Si narra che gli antichi Greci ponevano questi fiori sulla testa degli dei e li piantavano presso le tombe per significare che lo spirito non era mortale come la materia, e che godeva una vita nuova e beata negli Elisi. Omero racconta che gli abitanti della Tessaglia erano tutti coronati di amaranti nel giorno in cui si celebrarono i funerali di Achille.
Fu apprezzato anche dai Romani, che gli attribuivano il potere di tenere lontana l’invidia e la sventura. Plinio il Vecchio lo menzionò nella sua “Naturalis historia”: aveva notato che i suoi fiori, una volta raccolti, persino già appassiti, riprendono vigore se immersi in acqua, durando molto a lungo.
L’amaranto affascinò anche John Milton, celebre autore seicentesco inglese che nel suo capolavoro “Paradise Lost” cita l’amaranto come simbolo di immortalità.
Tra il Seicento e l’Ottocento, l’amaranto veniva utilizzato per ornare vestiti e abiti, in quanto si pensava fosse in grado di donare benessere fisico.
Non si hanno però notizie di un suo consumo alimentare in Europa.
Un certo utilizzo del chicco a tale scopo è storicamente noto, invece, in India e in Nepal; anche in Russia e in Cina se ne conoscevano le proprietà alimentari.
Ma in America Centrale e Meridionale l’amaranto ha avuto una storia completamente diversa.
Era coltivato già tra 7000 anni fa nella valle di Tehuacan, in Messico. Studi archeologici hanno confermato un ampio utilizzo di questo pseudocereale in tempi molto remoti, oltre che in Messico, anche nell’attuale Perù: si faceva utilizzo alimentare delle foglie, ricche di minerali, ma soprattutto del chicco.
Nonostante quest’ultimo sia assai meno conosciuto, quella del mais e quella dell’amaranto erano le due principali coltivazioni nelle terre messicane in epoca precolombiana, più o meno a pari merito.
Il consumo di amaranto era particolarmente importante nelle zone montuose afflitte dalla siccità.
Fu un cibo fondamentale, dunque, per olmechi, zapotechi, maya e, infine, per gli aztechi, che riunirono sotto il loro impero tutti ciò che restava delle civiltà precedenti. Antichi documenti attestano che l’amaranto era uno dei tributi più richiesti alle province dall’ultimo grande imperatore azteco, Montezuma.
L’amaranto veniva ammorbidito cuocendolo in acqua, si triturava e poi si impastava a mano per farne tortillas o tamales.
Si trattava di un alimento fondamentale per la vigoria del corpo e divenne sacro almeno quanto il mais. Aveva un ruolo centrale nelle cerimonie di ringraziamento agli dei che sovrintendevano al raccolto ed alle piogge: nei giorni prestabiliti, con la pasta di amaranto, arricchita di miele, le donne modellavano idoli di grandezza umana e con le sembianze degli dei, a cui venivano poi offerti. Durante le cerimonie, queste vere e proprie sculture di amaranto venivano inneggiate e poi spezzettate e distribuite ai presenti in modo da condividere la forza che rappresentavano. A volte prima di essere consumate venivano cosparse di sangue, proveniente da sacrifici umani. Tale pratica, per la somiglianza al rito dell’eucarestia cristiana, costò molto cara all’amaranto: Cortes ordinò che tutto l’amaranto fosse sradicato, disperso e fece bruciare centinaia di ettari di coltivazioni. A chi veniva trovato in possesso di piante e chicchi venivano tagliate all’istante le mani e se recidivo veniva ucciso. Sopravvissero perciò pochissime piante, nelle zone più impervie. Dal 1979, in seguito a una celebre conferenza sullo sviluppo rurale organizzata a Roma dalla FAO, iniziò il recupero dell’amaranto, insieme a quello di altri cibi tradizionali da recuperare per il loro alto valore nutrizionale.
Attualmente vi sono coltivazioni di amaranto a scopo commerciale in Messico, Sud America, Stati Uniti, Cina, India, Nepal, Russia, Polonia e Austria.
Le qualità nutritive dell’amaranto sono davvero eccellenti.
Contiene il 62% di carboidrati, costituiti essenzialmente da amido di altissima digeribilità, presente in granuli di dimensioni ridottissime (intorno a 1 μm, tra i più piccoli noti in natura) e straordinariamente omogenei in dimensioni e forma.
E’ ricco di proteine (mediamente il 16%) di buon valore biologico e facilmente digeribili: ha un buon contenuto di lisina e metionina, due aminoacidi carenti nelle Graminacee ed è ricco di arginina e istidina, amminoacidi essenziali per i bambini. Vi sono invece pareri contrastanti in letteratura su quale sia l’amminoacido limitante, se la leucina o la treonina: entrambi, tuttavia, sono contenuti in quantità adeguate nei cereali tradizionali. Utilizzando l’amaranto in combinazione con riso, grano o mais, quindi, si ottiene una miscela di proteine complete, ad alto valore biologico come pesce, carne, uova e latte.
Nell’amaranto abbiamo una percentuale di grassi più elevata rispetto ai cereali tradizionali, intorno al 7% (valore paragonabile a quello dell’avena). In essi vi è un’elevata quantità di acido linoleico, essenziale per la nutrizione umana (non può essere sintetizzato dal nostro organismo), di vitamina E (in quantità paragonabili all’olio di oliva) e di sostanze che hanno la proprietà di abbassare il colesterolo.
E’ ricco di minerali, in particolare calcio (a parità di peso, il doppio rispetto al latte), magnesio, ferro (5 volte più che nel grano), potassio, fosforo.
Contiene (oltre alla E) buone quantità di vitamine A, B₁, B₂, B₉ (acido folico), C.
E’ molto ricco di fibra alimentare.
Un altro aspetto straordinario dei semi di amaranto è dato dal fatto che le sostanze nutritive si concentrano in una sorta di “anello” che circonda il centro del seme, nel quale è contenuto l’amido. Per questo motivo le sostanze nutritive sono protette durante la lavorazione e le possiamo ritrovare pressoché intatte nel prodotto finito!
Tra le proprietà riconosciute all’amaranto ricordiamo che è un ottimo ricostituente psicofisico.
E’ particolarmente adatto ai bambini e ai ragazzi per la loro crescita.
Per la sua digeribilità, è adatto ad anziani, convalescenti, per lo svezzamento dei bambini, per le persone che soffrono di problemi intestinali.
Date la sue ottime proprietà nutritive, purché abbinato ad altri cereali, è un valido ingrediente nella dieta di tutte quelle persone che per un motivo o per l’altro decidono di non mangiare più la carne.
E’ dotato di proprietà emostatiche: per questo motivo, e per la sua particolare ricchezza in magnesio, è molto adatto alle donne nella sindrome premestruale, in caso di mestruazioni abbondanti e per aiutare a tenere in equilibrio l’umore. E’ utile nelle emorragie intestinali.
E’ sicuramente utile nelle anemie per la ricchezza in ferro e acido folico.
E’ astringente, come il riso.
Possiede attività diuretica.
E’ ricco di fibre particolarmente utili per la regolarità intestinale.
Aiuta a tenere sotto controllo i livelli ematici di colesterolo.
Sembra sia utile nel trattamento dei disturbi respiratori (in particolare il succo fresco, dolcificato con miele, si può utilizzare nella bronchite cronica, nell’asma, nei raffreddori, nelle influenze, ecc.).
Il decotto di chicchi di amaranto si può utilizzare contro la diarrea, nelle menorragie o come lenitivo nelle ulcere dell’apparato digerente (bocca, stomaco, intestino).
Le foglie fresche, la parte della pianta più utilizzata presso i popoli africani, hanno un ottimo contenuto di vitamine A e C e tanto ferro: vanno però cotte 15 minuti in acqua bollente.
Qualche difetto dell’amaranto? Quando cresce su terreni coltivati, specie se ricchi di azoto, può concentrare molti nitrati e altre sostanze nelle foglie risultando lievemente tossico; ha un’elevata quantità di ossalati ed è segnalata la presenza di nefrotossine.
Questo dimostra un’altra volta, se ce n’era bisogno, che il cibo perfetto non esiste!
Dott. Enrico Bernero
Farmacista e Naturopata
Se vuoi ricevere altre pillole, aggiornamenti e offerte esclusive iscriviti alla nostra newsletter