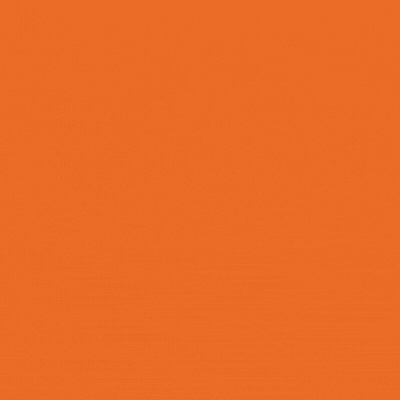Siamo a febbraio, e con la parola di oggi siamo perfettamente in tema. A febbraio c’è San Valentino, la festa degli innamorati! Ma cosa c’entra con il rapporto con i figli e la loro educazione? E’ un altro tipo di amore quello di cui parleremo oggi, no? In effetti così dovrebbe essere, ma non sempre è. Il rischio che qualche genitore porti a casa un mazzo di roselline al figlio e non al partner c’è. Anzi, ormai è cronaca quotidiana. Parola di fioristi!
Viviamo nell’epoca dei “genitori innamorati dei figli”. Lo testimoniano gli innumerevoli post su Facebook, con tanto di album fotografico di ogni momento della vita del figlio, colmi di cuori e di emoticon con gli occhi languidi. Lo testimoniano le maestre, soprattutto quelle della scuola dell’infanzia, che sempre più spesso devono gestire acrobatici colloqui con genitori che non possono sopportare che il loro bambino sia stato sgridato, magari si sia preso una spinta da un compagno di scuola, che quindi abbia pianto. Come se la sofferenza, minima e inevitabile in un percorso di crescita, fosse la loro. E diventa inaccettabile vedere il figlio ‘stare male’, proprio come avviene nel rapporto di coppia, in cui la sofferenza dell’altro è intollerabile. Perlomeno nella fase dell’innamoramento. Poi, come sappiamo, la coppia evolve e subentrano le routine; a volte, negli anni, l’altro diventa al contrario motivo di insofferenza.
Incredibile dictu! Accade anche con i figli: dopo anni di overdose affettiva verso gli adorati frutti del nostro grembo, immortalati in milioni di click, riempiti di baci e coccole, ci svegliamo una mattina e scopriamo che quel figlio tanto amato è diventato una serpe, un tiranno incappucciato in felpe oversize, silenzioso consumatore di beni materiali e di energie relazionali, incapace di un minimo di riconoscimento per tutto l’amore e le opportunità ricevute. Ops! Cosa è accaduto? Forse lo abbiamo amato “troppo”; o di un amore non materno e paterno. Caroline Thompson, nel suo interessante libro “Genitori che amano troppo – e figli che non riescono a crescere”, conduce proprio alcune riflessioni in questa direzione: “Si è verificata un’inversione di ruoli per cui non sono più i genitori a guidare i figli, ma sono i figli a dover sostenere i genitori smarriti, vittime di angoscia di separazione. E più i genitori sono angosciati, più i figli sono sommersi dal senso di colpa e oscillano tra sottomissione e ribellione, senza riuscire a trovare la via dell’indipendenza. Il figlio è sovrano, ma è un sovrano prigioniero del suo regno”.
Come ripartire allora nella giusta direzione? L’amore ha varie forme, alcuni funzionali nel rapporto genitori-figli, altre certamente malsane. Sulla Treccani, cercando la definizione di “Amore”, alla prima riga troviamo: “Sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercane la compagnia”. Interessante. Purché – parlando di figli – la compagnia abbia il limite dei 30 anni! Magari 25, che sarebbe più opportuno. E purché le mie azioni di genitore siano centrate sul bene del figlio.
Qui c’è la chiave di volta; concedetemi allora un gioco di parole: fare il suo bene è diverso da volergli bene. Voler bene è importante, certo! E normalmente ci viene facile. Quando “ci si vuole bene” c’è una reciprocità in quell’affetto che fa star bene anche noi adulti. Fa stare ‘al caldo’. Chi, come me, ha figli già più grandini, ricorda con nostalgia il piacere di un abbraccio con il proprio cucciolo di 2 o 3 anni. O i dolci disegni portati a casa per la festa della mamma a 4 o 5 anni! Fare il bene del figlio è assai più complesso, a volte sembra dissonante con l’idea di amore. Ma è amore anche questo, anzi è la forma di amore più difficile. Quella che lavora per promuovere le autonomie in un figlio, per esempio. Insistendo perché lui si vesta da solo, si lavi da solo, dorma da solo, studi da solo. Quella che non è morbosa, che accetta che vi sia una fase della vita dove gli amici sono tutto e tu genitore non conti più niente. E gli abbracci sono vietati. Per cui bisogna accontentarsi di fare una carezza col pensiero. Quella che sa lasciare andare, quando il figlio sedicenne vuole fare un’esperienza di studio all’estero. Quella che può anche dire di no alla richiesta del figlio di 13 anni di andare a una festa che finisce tardi, pur sapendo che il figlio soffrirà per quel divieto, per quella limitazione della sua libertà; perché è ancora troppo giovane per poterla gestire. E quindi amare è anche limitare. Ricordandoci che noi siamo la guida, coloro che sanno quale sia il bene dei figli; proprio perché li amiamo, non lasciamo sempre a loro il potere di scegliere e di decidere.
Sottolinea ancora la Thompson: “Ci facciamo vanto di trattarli come pari, e non ci accorgiamo che così non gli consentiamo di vivere la loro infanzia e non assolviamo al nostro compito di genitori, che si fonda sulla differenza e non sull’affinità. Non ci accorgiamo che amare troppo i figli significa anche esporli alla nostra delusione, perché non sempre riusciranno a essere all’altezza delle nostre attese. Significa pretendere che essi ci amino a loro volta. Significa privarli della libertà impedendo loro di emanciparsi”.
In conclusione, giusto per evitare equivoci, l’invito non è a non amare i figli. Ma ad amarli nel modo giusto. Di quell’amore genitoriale che non vincola, ma mette le ali. Non lega a sé, ma invita a correre lontano per conoscere il mondo. Perché i figli abbiano gli strumenti per volare alto, fuori dal nido familiare. Sicuri e forti, quando faranno le loro esperienze, perché avranno sperimentato l’amore vero, l’amore utile. E ne conserveranno una sana nostalgia, che sarà la spinta per donarlo ad altri.