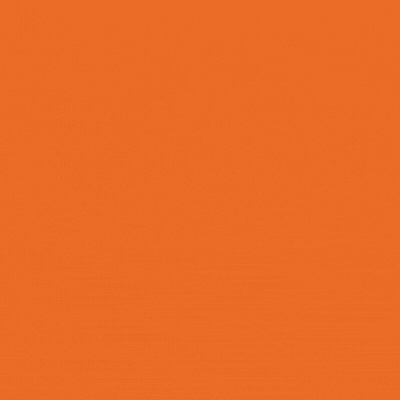Archiviato lo scontro tra difese e accusa sulle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, al processo “Geenna” – giunto alla terza udienza oggi, mercoledì 10 giugno – è iniziata la sfilata dei testimoni protagonisti degli episodi che, secondo i Carabinieri del Reparto operativo del Gruppo Aosta, dimostrano gli elementi fondanti della “locale” di ‘ndrangheta per cui sono alla sbarra il ristoratore Antonio Raso, il dipendente del Casinò Alessandro Giachino e il consigliere comunale aostano sospeso Nicola Prettico, tutti accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso (gli altri due imputati, il consigliere regionale sospeso Marco Sorbara e l’ex assessore di Saint-Pierre Monica Carcea rispondono di concorso esterno nel sodalizio).
Lavori al tunnel: i testi smentiscono l’accusa
In particolare, nelle deposizioni delle persone citate dal pm Stefano Castellani della Dda di Torino, sono state ripercorse vicende contestate al titolare della pizzeria “La Rotonda”, a partire dai lavori al Traforo del Gran San Bernardo. Per l’accusa, Raso sarebbe intervenuto sulla società di gestione “Sitrasb”, per far ottenere un intervento ad un artigiano “di fiducia” del sodalizio. Una segretaria dell’azienda ha detto di ricordare la telefonata con cui il ristoratore chiedeva appuntamento con l’allora presidente, Omar Vittone, per una persona. Ha poi testimoniato il supervisore dei lavori per l’impresa che li ha effettuati, confermando che l’artigiano avesse operato in subappalto, per delle opere in cartongesso, risalenti a “tre-quattro anni fa”, alla “dogana, uffici svizzeri e italiani”.
Quell’assegnazione, però – ha spiegato, smentendo la tesi accusatoria – non era stata né consigliata, né imposta dalla Sitrasb, ma avvenuta a seguito della comparazione di vari preventivi, con quello scelto risultato più conveniente. Un vantaggio economico tale da far sì che il cartongessista selezionato in quella circostanza, pagato direttamente dall’azienda come subappaltatore, venisse utilizzato anche in seguito. Riguardo a quei lavori, il geometra ha riferito di non aver mai avuto contatti con il vertice “Sitrasb” dell’epoca, perché “avevamo a che fare semplicemente con dei direttori, dei tecnici, per la parte svizzera e quella italiana”.
“Raso mai minaccioso con me”
E’ stato quindi sentito l’ex titolare di una discoteca cui, stando alle risultanze dell’inchiesta, Antonio Raso aveva telefonato chiedendogli di permettere nuovamente l’ingresso ad un cliente (ritenuto dai Carabinieri un suo “uomo di fiducia”), che era stato allontanato dal locale dopo uno screzio con il gestore. Il testimone lo ha definito “un episodio banale”, di quelli che accadono spesso a chi fa quel lavoro ed ha anche sottolineato spontaneamente che il ristoratore non ebbe un fare minaccioso nella conversazione. Precisazione non sfuggita all’avvocato di parte civile del comune di Saint-Pierre, Giulio Calosso, pronto a chiederne conto al teste, vista l’assenza di contestazioni in merito da parte dell’accusa.
L’uomo ha quindi spiegato di essere “rimasto stupito dall’arresto di Raso”, da lui “sempre visto come un buon ristoratore”, dal quale mangiava spesso. “Se conosci una persona ci rimani male – ha aggiunto – e ci ho tenuto a specificare” quell’aspetto “perché se lui è stato arrestato per motivi come il mio, è stato una cavolata”. Peraltro, a detta del gestore, “succede tutt’ora che qualcuno mi chiami e mi chieda perché una persona ‘non può entrare’”.
“Ero tranquillo perché c’era Tonino”
I testimoni successivi hanno riguardato il presunto intervento di Raso per risolvere la tensione creatasi tra la famiglia di suo nipote ed il 53enne Salvatore Filice, a processo con rito abbreviato nel procedimento su “Geenna” al Tribunale di Torino, per tentata estorsione e violazione delle norme sulle armi. La vicenda ha origine, come ha riferito il nipote del ristoratore in aula, dalla notte in cui lui e il figlio di Filice “fuori da una discoteca”, si sono “azzuffati per una ragazza”. Da quel momento, “il padre è venuto a cercarmi”. Dopo un primo incontro, in cui “improvvisamente, mi ha tirato un pugno”, Filice convoca il giovane assieme ad un parente nel suo locale, un night di Châtillon.
Quella sera, hanno evocato i testimoni, chiede loro dei soldi, 10mila euro, “per i danni riportati dal figlio”, mostrando loro una pistola e minacciando “un buco in testa”. Nonostante l’uso di un arma, i diretti interessati non si rivolgono alle forze dell’ordine, perché – ha affermato il ragazzo – “temevamo che Filice potesse fare qualcosa alla nostra famiglia, a mia sorella”. L’episodio viene invece riferito ad Antonio Raso. Un cammino preferito perché, lo ha motivato il parente del ragazzo, “non volevamo creare problemi”. Ha riferito anche di non essersi più interessato alla questione dopo aver coinvolto il ristoratore, perché “ero tranquillo che c’era Tonino”.
Una frase che ha fatto sbottare nuovamente l’avvocato di parte civile Calosso, che ha chiesto: “Quale sarebbe stato il ruolo di Tonino?”. La risposta del testimone “Conosceva tante persone” ha innescato immediatamente un’altra domanda: “Basta conoscere tante persone, per avere la certezza che un problema si risolva?”. “Penso che conoscendo – ha concluso l’uomo – si possa parlare civilmente per risolvere”. La madre del ragazzo vittima della presunta estorsione, ascoltata subito dopo, ha rivelato che “mio figlio non mi ha raccontato nulla” e di aver appreso della questione dai giornali, con l’apparire dei primi articoli sull’indagine. Agli inquirenti aveva detto che “lo zio Tonino” disse al giovane “di non parlarmi” e “penso che fosse perché sono una persona ansiosa e non volessero preoccuparmi”.
Viérin? Ignaro dei precedenti di Di Donato
Nel pomeriggio, con la deposizione dell’impiegato e sindacalista del Casinò Massimo Raffaelli, è rivissuto in aula l’incontro del 2018 tra l’ex assessore regionale Laurent Viérin e Roberto Alex Di Donato, arrestato in “Geenna” e a processo anch’egli nell’udienza dinanzi al Gup di Torino Alessandra Danieli, perché ritenuto altro “partecipe” della “locale” ndranghetista aostana. Raffaelli ha detto di essere “iscritto all’Union Valdôtaine Progressiste” e di aver, all’epoca, “sostenuto la candidatura” di Viérin, anche perché “conosco e stimo da tempo il papà” (l’ex presidente della Regione, Dino, ndr.).
In quell’incontro, monitorato dai Carabinieri nell’indagine “Egomnia” (sul condizionamento che la ‘ndrangheta avrebbe esercitato sulle elezioni di quell’anno per il rinnovo del Consiglio Valle) Roberto – che rimase colpito perché “come Viérin aveva perso la mamma in quel periodo” – si offrì “di organizzare un aperitivo, per far conoscere dei possibili simpatizzanti ed elettori”. Ebbe luogo alcuni giorni dopo “al bar Nord” e “c’eravamo io, Alessandro Giachino, Roberto Di Donato e Laurent Viérin”, oltre a “6-7 persone che non conoscevo”. “Non penso – è stata la spiegazione del testimone – che siamo stati lì più di 20 minuti. Abbiamo bevuto una birra. Viérin, che forse aveva un comizio elettorale, è andato via per primo”.
Il testimone, poco prima, aveva detto di essere al corrente dei problemi con la legge avuti da Di Donato (arrestato e condannato per traffico internazionale di stupefacenti, ndr.), perché lo conosceva fin da piccolo, e di essersi preoccupato quando aveva saputo che il suo collega Giachino (definito “un amicone, sempre iperdisponibile con tutti”) condivideva un’attività lavorativa assieme al fratello Marco Fabrizio, tanto da domandargli conto del loro rapporto per ben tre volte. A quel punto, il pm Castellani non ha potuto trattenersi dall’approfondire se gli fosse mai capitato di parlare con Viérin della situazione di Di Donato? “Sì, lui era ignaro. Glielo ho detto io”. E, ha incalzato il rappresentante dell’accusa, “proprio perché si era preoccupato per Giachino, non ha valutato che potesse essere poco opportuno, per Viérin” conoscerlo? Risposta: “Col senno di poi, sì. All’epoca, no”.
L’intimidazione scoperta dai giornali
Altro filone esplorato in giornata, la presunta intimidazione del gennaio 2016 nei confronti del titolare di un noto ristorante di Aosta, “La Grotta Azzurra”, che intratteneva rapporti di amicizia sia con Antonio Raso, sia con Marco Fabrizio Di Donato (individuato dall’inchiesta come il capo della “locale” e altro imputato nel procedimento torinese). Per gli inquirenti, il ristoratore, trovatosi a ristrutturare la futura sede della sua attività, avrebbe ricevuto “consigli” di affidare i lavori ad artigiani “più graditi” alle sue amicizie di quelli individuati dallo studio di architettura cui si era rivolto. L’uomo, Sandro Anastasio, ha però detto in aula di “aver appreso delle minacce nei miei confronti leggendo i giornali”, all’indomani dell’emergere dell’inchiesta, con il “blitz” del 23 gennaio 2019.
Il professionista responsabile della ristrutturazione, chiamato a seguire, ha spiegato che “Anastasio conosceva delle persone e ha chiesto a me di procurare comunque dei preventivi, dalle ditte con cui ero solito lavorare, o che magari conoscevo”. A quel punto, “ho fatto un elenco delle opere, chiedendo per ognuna più preventivi, anche cinque”. Il capitolato è stato dato anche al titolare del ristorante e, sulla base di esso, lui “ha chiesto” offerte agli artigiani con cui era in contatto. Dopodiché, “abbiamo valutato” li preventivi e scelto. La ditta per le opere di muratura era tra quelle conosciute da Anastasio. “Era la prima volta che ci lavoravo e avevo dei timori, – ha commentato l’architetto – però poi mi sono trovato molto bene”.
Ne ha discusso con il titolare del locale? “No, lui si fidava. Una volta che il cliente ha scelto, io sono sereno”. Peraltro, “abbiamo valutato assieme a Sandro le differenze” tra i due preventivi (che presentavano un’offerta complessiva dissimile), poi “lui ha concluso ‘ci parlo io’”. Quanto alle maestranze che hanno poi lavorato sul cantiere, evocate come “quasi tutte calabresi”, il testimone ha sostenuto di non ricordare di aver fatto la battuta finita nelle carte dell’inchiesta, quella in cui avrebbe rinfacciato al committente dei lavori di aver dato “i lavori ai tuoi amici perché sono della ‘ndrangheta”. Per la verità, più di uno oggi sono stati i momenti in cui il pm Castellani si è trovato a contestare dimenticanze od omissioni a testimoni che avevano reso dichiarazioni maggiormente dettagliate alla polizia giudiziaria, all’epoca delle indagini.
“Siamo una piccola comunità…”
Tra un “non ricordo, sono passati tanti anni”, destinato a trasformarsi dopo le contestazioni in “se allora ho detto così, sarà andata così”, il Pubblico ministero si è sentito anche rispondere: “Siamo una piccola comunità, tutti sanno tutto”. E forse inizierà a pensare che proprio questo sia un aspetto ben più centrale nel processo di quanto non gli apparisse prima dell’inizio del dibattimento. L’udienza riprenderà alle 9.30 di domani, giovedì 11 giugno, con altri testimoni citati dall’accusa. Sul procedimento torinese, invece, c’è da registrare uno slittamento del calendario. La sentenza (i presunti componenti della “locale” che hanno scelto l’abbreviato sono i due fratelli Di Donato, Francesco Mammoliti e Bruno Nirta), attesa originariamente per domani, dovrebbe arrivare, dopo l’inserimento di altre due udienze, il 17 luglio prossimo.