La “locale” di ‘ndrangheta aostana al centro dell’indagine “Geenna” di Carabinieri e Dda di Torino? Non solo esisteva, ma non era “una neoformazione o microassociazione in fase di creazione”, bensì “una struttura delocalizzata” del crimine organizzato, frutto di un “mutamento dei rapporti e dei collegamenti con la casa madre calabrese, con spostamento del baricentro dalla ‘ndrangheta tirrenica a quella ionica”. Insomma, una “mera gemmazione” della cellula “già esistente nei decenni precedenti” in Valle.
Lo scrivono i giudici della terza Sezione della Corte d’appello di Torino, nelle 375 pagine di motivazioni, depositate nelle ultime settimane, alla sentenza con cui, lo scorso 30 settembre, hanno condannato, per associazione di tipo mafioso, il ristoratore Antonio Raso (8 anni di reclusione) e gli ex dipendenti del Casinò Nicola Prettico e Alessandro Giachino (6 anni e 8 mesi ognuno), nonché assolto Monica Carcea (“perché il fatto non sussiste”) dall’accusa di concorso esterno nell’associazione.
L’“appello bis”
Era l’“appello bis” relativo al dibattimento ordinario del processo Geenna, cui si era arrivati dopo che la Cassazione, il 24 gennaio 2023, aveva annullato le condanne riportate dai quattro imputati nei primi due gradi del procedimento (al Tribunale di Aosta e in Corte d’Appello a Torino), stabilendo il ritorno dinanzi ad altri giudici di secondo grado. La Suprema Corte aveva riscontrato carenze motivazionali riguardanti, in particolare, il collegamento della “locale” aostana con la “casa-madre” calabrese e di alcuni elementi distintivi delle “particelle” mafiose, come la capacità di intimidazione.
L’ingerenza nella vita della regione
Per i giudici, nell’“appello bis” sono “emersi plurimi elementi che dimostrano l’esercizio in concreto di specifiche condotte intimidatorie” e “vicende che provano la capacità di controllo del territorio e di imposizione di regole e condotte su altri soggetti, influendo e ingerendosi, attraverso tali metodi, nella vita economica e politica della Regione Valle d’Aosta”.
Malavita calabrese, una presenza risalente
Ripercorrendo vicende delittuose degli anni ’80 e ’90 (gli omicidi Manti, Mirabelli e Neri), assieme a pregresse indagini svolte nel tempo (“Lenzuolo”, “Tempus Venit”, “Hybris”, e “Gerbera”, ma anche “Minotauro” sulle infiltrazioni nel vicino Piemonte), i magistrati sottolineano come “il territorio valdostano fosse interessato dalla presenza di soggetti operanti all’interno della compagine criminosa di matrice calabrese quantomeno dagli anni ’70-‘80”.
Un contesto per cui – si legge nella sentenza – nell’ambito del processo “Geenna”, attraverso intercettazioni e altre prove raccolte, è “stata acquisita la prova di una vera e propria contaminazione di natura ‘ndranghetista della comunità valdostana, perdurante nel tempo e tale da rendere esplicita e ben percepita la presenza dell’organizzazione criminale sul territorio”.

Palesato anche il legame con la “casa madre”
In varie vicende finite nei diversi capi d’imputazione, scrivono poi i giudici, “risulta che gli appartenenti al sodalizio abbiano agito in modo unitario a tutela degli interessi comuni e/o a difesa dei propri associati, venendo percepiti all’esterno come appartenenti ad un gruppo unitario, organizzato a strutturato, in grado quindi di esprimere una forza intimidatrice propria e palesando anche il legame con la casa madre calabrese”. Non solo, perché ricorrono anche “elementi strutturali tipici dell’associazione”, sussistendo “un’organizzazione gerarchica con ripartizione dei compiti e delle funzioni tra i vari affiliati”.
L’attitudine di “basso profilo”
Le investigazioni svolte in “Geenna” (ad indagare è stato il Nucleo Investigativo del Gruppo Aosta dei Carabinieri) hanno evidenziato “quanto già emergeva in precedenti indagini”, vale a dire che “la ‘ndrangheta in Valle d’Aosta – al di là di specifici episodi di natura illecita, estorsiva od altro, che maggiormente si rinvengono nei decenni precedenti – abbia tenuto un atteggiamento di ‘basso profilo’, evitando la commissione di condotte platealmente illecite” , che costituiscono “tipica cifra comportamentale delle organizzazioni criminali di stampo mafioso per dedicarsi maggiormente a intrecciare relazioni con esponenti del mondo politico, amministrativo e imprenditoriale, per ottenere vantaggi e profitti partecipando alla spartizione dei lavori pubblici”.

Carcea, le ragioni dell’assoluzione
Da qui, le condanne dei tre imputati accusati di aver partecipato alla “locale” (la cui esistenza era già stata sancita dalla sentenza, divenuta definitiva nell’aprile 2023, per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato: Bruno Nirta, Marco Fabrizio Di Donato, Roberto Alex Di Donato e Francesco Mammoliti). L’assoluzione di Monica Carcea dall’imputazione di concorso esterno, per i giudici d’appello, è invece frutto della “mancata acquisizione di elementi di prova univoci e adeguati sui concreti vantaggi conseguiti dal sodalizio criminoso per merito e/o grazie all’attività” dell’imputata.
Ciò, però, non sgombera il campo – è scritto in sentenza – da “stretti ed inquietanti legami tra la medesima e il marito – da un lato – e Di Donato e gli altri affiliati – dall’altro – di cui risulta che i primi comprendessero pienamente la capacità di orientare le preferenze elettorali, di esercitare le proprie “pressioni” per evitare che la giovane politica subisse l’ostracismo di altri esponenti politici ed al contempo di favorire la sua ascesa nell’agone politico locale”.

La candidatura non nata nella “locale”
Nel processo, in sostanza, non è stato “dimostrato al di là ogni ragionevole dubbio che” Carcea “abbia posto in essere condotte causalmente efficienti, secondo una valutazione ex post, a rafforzare la consorteria di stampo ‘ndranghetistico”. I giudici osservano infatti che “la candidatura” dell’attuale imputata “alle elezioni comunali di Saint-Pierre del 2015 non sia nata all’interno della locale”, che “aveva addirittura inizialmente puntato su candidatura di diverso schieramento, salvo appoggiarla, allorché Di Donato e Raso apprendevano della sua candidatura”.
Esclusa l’ipotesi del reato di voto di scambio politico-mafioso (su tale imputazione, per le elezioni di Saint-Pierre, la sentenza è stata di assoluzione), pur emergendo dalle indagini che Carcea, una volta divenuta assessora, “abbia trovato ‘punti di riferimento’ per lo svolgimento della sua attività in Antonio Raso e Marco Fabrizio Di Donato”, non “risulta dimostrato” che l’appoggio elettorale “sia stato frutto di un accordo sinallagmatico in base al quale, a fronte della promessa di voti, l’inesperta candidata si impegnava ad assicurare utilità alla consorteria mafiosa attraverso la propria attività all’interno dell’ente territoriale”. Semplificando, contiguità sì, concorso no.












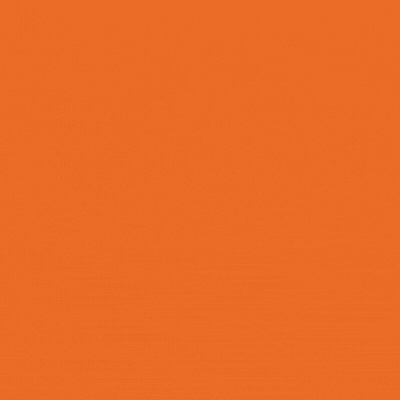

2 risposte
Questa città è piena di infiltrazione malavitosa a tutti i livelli. I valdostani fanno finta di nulla perché gli conviene, per mantenere il loro posto privilegiato in regione o presso una partecipata regionale. La qualità della vita è precipitata a livelli miseri, la qualità delle istituzioni pure. Siamo diventati la vergogna d’Italia!
Bravo Diémoz e bravi ad Aostasera; questi articoli sono necessari per far sì che la comunita’ VDA sviluppi la capacità di bloccare le infiltrazioni di individui di questo tipo e rifiuti la cultura e la mentalità tipiche dell’ ndrangheta calabrese in tutte le sue forme, anche quelle apparentemente più innocue e non palesemente illegali.